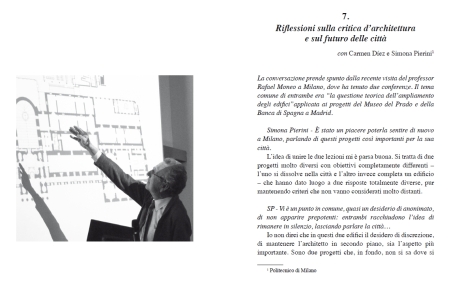Il giovane critico americano, che nel 1931 stava girando per l’Europa a raccogliere i documenti per quella che sarebbe divenuta la famosa mostra sull’International Style, rimase colpito dalla visita compiuta a Berlino all’esposizione L’abitare del nostro tempo, dove Mies van der Rohe aveva esposto una serie di pannelli con le lamine delle venature di differenti legni, appese, ci racconta, come allora si faceva solo con «i quadri nelle regge»[1]. Per chi conosce l’architettura di Mies non è certo una sorpresa associare al suo nome l’eloquenza dei materiali, ma quello che stupisce è che questo interesse possa diventare il tramite per affrontare il tema della casa popolare e della sua realizzazione alla grande scala della metropoli moderna, tema allora pressante nel dibattito internazionale.
Mies espone lamine di legno, mostra sezioni di alberi, spaccati che esibiscono in ogni venatura un anno dopo l’altro, una storia lunga, così lunga da diventare senza misura di tempo, di nuovo primordiale. Mies allude all’importanza della scelta, sapendo come ogni taglio sia diverso dall’altro, per tipo, per materia, per colore, per durezza, per età: sarà la semplice scelta dell’artista che ne porterà uno solo in casa Tugendhat; ma è anche vero che ogni lamina è esposta come un quadro: viene considerata un capolavoro, è bella come un’opera d’arte.
In queste opere Mies van der Rohe non è interessato alla tradizione costruttiva di un materiale, cancella la complessità della storia della costruzione per tornare al carattere primordiale della materia pura, quasi a suggerire una teoria[2] fondata sulla sensibilità.
Anche le grandi lastre di marmo e di onice esposte a Barcellona, le scelte uniche, irripetibili, del figlio dello scalpellino diventate pareti, si esibiscono come sezioni tirate a lucido di una cava antica e sono affiancate agli sfuggenti riflessi[3] del nuovissimo acciaio cromato: da questo ossimoro temporale poteva nascere l’architettura moderna.
Sulla mostra di Berlino e su Mies il raffinato e sensibile critico Philip Johnson tornerà più volte, forse proprio perché intuiva il coraggio del raccontare il valore estetico della materia, la volontà di metterla in mostra come unico strumento efficace per liberarsi dall’obbligo convenzionale, figurativo, della forma, delle forme storiche. Materia come semplice scelta dell’artista.
Anche in Asplund la materia ha un ruolo importante: il progetto per l’ampliamento del Municipio di Göteborg, le cui prime proposte datano già nel 1913, viene sviluppato più volte nei suoi tratti essenziali fino al 1935-37, gli anni della realizzazione; i temi del progetto, il grande spazio centrale e il ruolo attribuito al basamento che determina il nuovo piano nobile, sono chiari e perseguiti fin dai primi studi, e trovano sintesi nel grande vuoto della hall, illuminata dall’alto e aperta verso la corte dell’attiguo palazzo. Se è oggi possibile studiare la sequenza delle molte e diversificate varianti al progetto fino al momento della stesura definitiva[4], e constatarne la continuità del linguaggio classicista, affinato con basamenti in pietra, pilastri e colonne, non si può non restare colpiti dalla soluzione realizzata, completamente diversa proprio nel linguaggio. Dopo il viaggio in Europa in occasione del suo incarico per l’Esposizione Internazionale di Stoccolma del 1930 – abbiamo testimonianza delle visite a Brno e a Parigi – Asplund trasforma completamente il linguaggio dell’edificio, sostituendo una composizione fatta di elementi con un movimento dello spazio ottenuto grazie alle curvature delle grandi superfici in legno. Materia come linguaggio.
Potremmo elencare diversi momenti di crisi in cui si fa ricorso alla materia, come nel crollo di certezze del secondo dopoguerra e ricordare come anche Ernesto Nathan Rogers si senta nuovamente in dovere di educare alla sensibilità, pubblicando con insistenza sulla sua Casabella-continuità le belle fotografie di Werner Bischof dei particolari materici dei grandi monumenti arcaici[5]. Di nuovo ritroviamo la concretezza della pietra, e nello stesso tempo la forte astrazione della materia portata alla luce, ma nel caso di Rogers ogni momento è «inserito nel dramma dell’esistenza» e non può essere considerato entità astratta: per lui la materia è lo strumento per la rappresentazione di un momento storico attraverso la sua realtà costruttiva. Ed è proprio la concretezza della costruzione nella materia a liberare la forma dalla banalità della sua ripetizione e a obbligare ogni artista a scoprire relazioni inedite tra materia e costruzione.
Possiamo quindi azzardare che nei momenti di cambiamento, nelle fasi di passaggio e di riflessione operativa sull’architettura vi sia un ritorno alla materia: questo è avvenuto per il moderno, e questo avviene oggi, anche se in forma diversa. La bellezza della cruda materia in Mies, la materia come linguaggio in Asplund, materia e realtà costruttiva per Rogers. Sempre la libera scelta della materia in contrapposizione all’obbligo della forma. Materia versus forma.
Queste riflessioni preliminari ci introducono al cuore del libro, Madre Materia, il cui autore, già noto in Italia per un volume in parte complementare a questo, Il vuoto, ci ha già iniziato ad una modalità di scrittura fatta di riflessioni che inseguono un tema attraverso le molte interpretazioni, anche extradisciplinari, che questo può suggerire. Fernando Espuelas indaga, infatti, in questo saggio i termini che incidono sul concetto di Materia secondo una modalità di montaggio del testo anch’esso, potremmo dire, materico: una serie di concetti mostrati nella loro naturale complessità, affiancati l’uno all’altro come le lamine delle venature di Mies, dove il lettore può scegliere e rimontare le questioni, senza l’imposizione di una tesi e di una sequenza predeterminata. Vi è una componente fortemente progettuale in questo punto di vista: la possibilità cioè di scegliere l’idea del progetto a partire dalla materia e non dalla forma.
L’autore del libro si colloca dunque in continuità con quella corrente del pensiero contemporaneo, già assestata nella cultura spagnola con il libro di Iñaki Abalos La buena vida, in cui sensibilità e percezione diventano parte attiva di un pensiero soggettivo sulle scelte artistiche: il volume offre una serie di parole chiave per ripensare i valori primari dell’architettura, allontanandoci dalle forme precostituite. In questo senso si offre come un atlante, un inventario, che ben si inserisce nel panorama della poetica contemporanea, abituata a lavorare sulla breccia, sulla rovina, sul frammento e la sua sineddoche, aprendo alla fantasia di ogni possibile tutto, ma che rimanda all’intero solo con l’allusione. Proprio nel saggio su frammentazione e compattezza Rafael Moneo ha analizzato in maniera lucida questa condizione del contemporaneo che rifugge la forma: «La forma è legata a ciò che è permanente, ostacolando il potenziale racchiuso nel futuro, ed è perciò caduta in disgrazia»[6].
In questa condizione del contemporaneo, la materia torna a essere un utile strumento di lavoro. Nelle librerie oggi è ormai possibile trovare sugli scaffali libri interi fatti di immagini, dove, sfogliando patinate pagine a colori, si entra nei mondi personali degli autori[7], la cui comunicazione prevalente è quella materica; spesso si riconoscono alcuni dettagli, si intuisce una familiarità con la nostra memoria di studiosi di architettura: in mezzo ai più sconosciuti reperti di un mondo materico anonimo, si scopre un frammento di Zumthor, un pezzo di Asplund, ma anche uno spigolo di Le Corbusier o una texture di Lewerentz, ritrovando i maestri solo perché osservati a lungo, perché non si è potuto fare a meno di andarli a conoscere nella loro matericità.
Queste pubblicazioni hanno una genealogia nobile nell’opera scritta e costruita dagli architetti svizzeri Herzog & de Meuron. Già negli anni Ottanta, in un momento in cui l’architettura in Italia veniva fatta con i pantone e in Spagna Rafael Moneo sentiva l’esigenza di costruire gli imbotti profondi di Bankinter, gli allievi zurighesi di Aldo Rossi, con le loro opere costruite hanno saputo spostare l’interesse degli architetti più sensibili dalle ormai sterili forme storiche alla potenzialità della materia; solo recentemente questo approccio ha trovato esito compiuto in un catalogo pubblicato[8] dal CCA sulla loro opera giustamente intitolato Natural History. Il volume, che non appartiene più alla categoria dei testi teorici da leggere dall’inizio alla fine, si presenta invece come una raccolta di materiali: in questo caso scritti di autori diversi e interviste sono intrecciati con i frammenti materici e visivi cari alla loro poetica. L’atteggiamento progettuale e artistico degli autori non a caso rende esplicito il riferimento alle infinite pagine che compongono l’affascinante Atlas di Gerhard Richter[9], in cui le pennellate, la loro materia, il loro colore sono scelte dall’artista e montate in serie, in campionature sperimentali. Anche le infinite foto dei cieli, così come gli acquarelli di Venezia di Turner, non sono altro che prove, centinaia di prove di colori, prove di accostamenti, prove di definizione di una massa, di una materia non ancora riconducibile a forma. Ma l’aspetto più interessante dell’opera di Herzog & de Meuron è forse il fatto che questa liberazione dalle forme del passato permette di tornare a riflettere sui concetti operativi propri della disciplina, ragionare nella pratica sul significato di alcune operazioni compositive strettamente vincolate dalla sensibilità dell’artista, come la scelta dell’uniformità, della ripetizione, della compatezza, ma anche della frammentazione, del non-finito, del montaggio.
E così, proprio nell’indice di Natural History, riacquistano senso parole come trasformazione e straniamento, appropriatezza e variazione, accumulo e compressione, permettendo al lavoro dell’uomo sulla materia di dimostrarsi come imprescindibile per compiere il passaggio obbligato dalla natura alla materia.
Se da un lato infatti l’uso immediato della materia ci riporta all’idea della natura, bisogna osservare in verità che la materia usata in architettura si trova all’interno delle montagne, nei boschi, nelle miniere, che non si dà senza il lavoro dell’uomo. «Queste materie, sorte dalla natura ma non naturali, [sono] prodotti dalla fatica umana e il racconto della loro lavorazione… affiora attraverso i segni della cultura materiale… Si ha l’impressione che questi oggetti, apparentemente elementari, contengano, proprio per questo processo di accumulo, una sequenza di tempo condensato»[10].
Una condizione temporale eccezionale si dice: da un lato senza tempo, e dall’altra sempre in contatto, tramite il lavoro dell’uomo sui materiali, con gli avanzamenti più attuali della tecnica della costruzione. Anche questo doppio aspetto è una declinazione nel tempo dell’immediatezza della materia.
Un’immediatezza in verità utile al progetto contemporaneo, che si trova oggi in una fase di ripensamento e ha trovato nuovamente nella materia il punto da cui ricominciare, riscoprendo e facendo proprio alcuni caratteri specifici dei singoli materiali.
La materia, le poche materie di base dell’architettura, naturali e fabbricate, aprono i Quattro libri dell’Architettura di Andrea Palladio: le pietre, quelle naturali e quelle cotte dall’uomo (i mattoni) i legnami, le arene e i metalli, a cui possiamo aggiungere in epoca moderna il vetro. Da queste poche materie possiamo ottenere i molti materiali da costruzione e i diversi caratteri che alla nostra architettura vogliamo dare: ci sono le famiglie della durata e dell’accoglienza, ma anche quelle dell’ambiguità e dell’aggressività, della trasparenza o dell’opacità, purché si conoscano le proprietà specifiche di ogni materia, come ad esempio la proprietà di diffusione o di riflessione della luce. Se l’intuizione palladiana del potenziale scultoreo delle arene, si trasforma in epoca moderna nei grandi getti del cemento armato, acquistando la dignità di una nuova materia nel raggiungimento dei suoi valori scultoreo-plastici, in realtà è solo il vetro che cambia profondamente la consistenza materica dell’architettura recente.
Il carattere sovversivo della nozione di smaterializzazione era già stata utilizzato da Mies van Rohe nei progetti degli anni venti per il grattacielo per la Friedrichstraße, dove la scelta del vetro è espressa proprio per attenuare l’impatto del nuovo tipo edilizio, il grattacielo appunto, sulla città antica[11].
Anche le sperimentazioni contemporanee più interessanti sullo spazio, come le opere della giapponese Sejima, sono tutte fondate sull’ambiguità nell’uso dei materiali: riflessi e sovrapposizioni di vetri, ma anche l’uniformità della materia come nuova soluzione progettuale.
Se caratteristica dell’architettura è quella di non poter negare, la materia permette anche di giocare sui paradossi: così la vernice lucida spennellata sulle grandi superfici in cemento armato delle opere di MVRDV o la finezza del rivestimento ceramico della splendida casa di Perret in rue Franklin.
Abbiamo già detto che la materia diventa linguaggio, in realtà si sostituisce alla complessità del linguaggio con la sua fisicità. Ferdinando Scianna ricordava proprio questo come uno dei caratteri della fotografia[12], del suo distinguersi dalla pittura: nel secondo caso l’immagine è creata dall’uomo, mentre nel primo viene trovata dall’uomo. Questa condizione di ritrovamento, dove la componente casuale assume una sua importanza è da associare con un’altra condizione del contemporaneo che ben è rappresentata da quell’objet trouvé che Rem Koolhaas costruisce come Casa della Musica a Oporto: in questo caso sembra addirittura che l’architetto olandese voglia rappresentare un frammento di materia caduto sulla terra.
L’immediatezza della materia sembra dunque assolvere, in epoca contemporanea, alle tematiche dell’architettura che non possono essere eluse, ai suoi caratteri fondativi, ma che non si possono più affrontare con gli strumenti disciplinari e compositivi tradizionali. È così possibile, ad esempio, parlare di un luogo semplicemente con la scelta della sua materia, così come alludere alla memoria con la sensibilità di una materia in contrapposizione all’imposizione di una figura, che spesso assume tratti caricaturali.
In questo modo l’architettura può anche rendere esplicite le influenze delle altre arti, basti pensare alla strettissima relazione che lega progetti recenti alla Land art o ad una determinata corrente del minimalismo, fondata sulla comune comprensione delle possibilità che la materia offre.
Senza il controllo del tempo, dello spazio e della misura, l’architettura sceglie dunque l’immediatezza della materia: la fiducia della solida pietra, il ritmo inesorabile degli infiniti mattoni, l’accoglienza delle morbide curve del legno, l’astrazione dei riflessi del vetro, la forza del ferro sono ready made per la sensibilità dell’architetto, ma anche per quell’abitante del quotidiano che la deve vivere. Ci dice André Breton, nel suo Dictionnaire abrégé du surréalisme nel 1924, che il ready made è: «oggetto usuale, promosso alla dignità di oggetto artistico dalla semplice scelta dell’artista». Semplice scelta dell’artista. Semplice!
Luglio 2012
[1] Philip Johnson and the Museum of Modern Art, MOMA, New York, 1998, p. 42.
[2] Nelle poche righe scritte che Mies van der Rohe ci ha lasciato, nelle stesse pagine della rivista « G » da cui aveva scagliato l’anatema contro la forma, riscatta il materiale tra i temi fondativi della nuova architettura, vedi Ludwig Mies van der Rohe, “Costruire” e “Costruire industrialmente”, in Mara De Benedetti, Attilio Pracchi, Antologia dell’Architettura Moderna, Zanichelli, Bologna, 1988, p. 399-401. Cfr. anche Fritz Neumeyer, Mies van der Rohe. Le architetture, gli scritti, Skira, Milano, 1996.
[3] Bruno Reichlin, “Conjectures à propos des colonnes réfléchissantes de Mies van der Rohe” in La colonne, nouvelle histoire de la construction, sous la direction de Roberto Gargiani, PPUR, Losanna, 2008.
[4] José Manuel López-Peláez, La arquitectura de Gunnar Asplund, Fundacíon Caja Arquitectos, Barcellona, 2002.
[5] «Gli oggetti diventano antichi quando hanno superato di essere vecchi, ma questa è qualità di pochi esempi selezionati. Quando diventano antichi ridiventano patrimonio attuale e possiamo farne uso pratico e quotidiana consumazione culturale». Questo l’incipit dell’articolo del 1964 “Le Corbusier”, in Ernesto Nathan Rogers, Editoriali di Architettura, Einaudi, Torino, 1968.
[6] Rafael Moneo, “Paradigmi di fine secolo: frammentazione e compattezza nell’architettura recente”, in L’altra modernità, Considerazioni sul futuro dell’architettura, Christian Marinotti, Milano, 2012, p. 59.
[7] Cfr. John Pawson, A visual inventory, Phaidon, Londra, 2011.
[8] Philip Ursprung, a cura di, Herzog & de Meuron: natural history, CCA, Montreal, 2003.
[9] Gerhard Richter, Atlas der Fotos, Collagen und Skizzen, Oktagon, Colonia, 1998.
[10] Massimo Fortis, “Materia e forma”, in Ghitti, memoria del ferro, Mazzotta, Milano, 2006, p. 57.
[11] Bruno Reichlin, “Quant’è trasparente il vetro?”, in Franz Graf e Francesca Albani, a cura di, Il vetro nell’architettura del 20° secolo: conservazione e restauro, Mendrisio Academy Press, Mendrisio, 2011, p. 162.
[12] «Perché la natura specifica della fotografia, e in questo risiede la sua straordinaria, gigantesca rivoluzione, è che per la prima volta non dà conto di un’ immagine “fatta” dall’ uomo, ma “trovata” dall’ uomo: nella realtà, nel mondo», Ferdinando Scianna, Le trovate d’artista non bastano più. L’estetica è nella necessità dell’opera, in « la Repubblica », 26 giugno 2012.
Viaggio a Madrid e Porto
Viaggio nei Paesi Baschi
Alzuza
Arantzazu
Donostia

Sommario
PROLOGO
MODERNO – Grandi e nobili orfani e altri testi di Alejandro de la Sota
MATERIA – Dalla materia all’astrazione di Orsina Simona Pierini
EQUILIBRIO – Lezioni d’equilibrio di Juan Antonio Cortés
STRUTTURA – Percorrendo Sota. Riflessioni sulla Gimnasio Maravillas di José Manuel López-Peláez
VUOTO – Costruire, abitare di Juan Navarro Baldeweg
CASA – Paura di toccare la terra di Moisés Puente, La Casa Varela – Estratto dal testo di Manuel Gallego
MATERIALI – Testi di Alejandro de la Sota
DETTAGLI – Arquitectura sin trabajo Josep Llinás
APPARATI – Biografia, Bibliografia, Origine dei testi e fonti delle immagini
Dalla materia all’astrazione
Con l’analisi dell’edificio del Gobierno Civil di Tarragona di Alejandro de la Sota, mi interessa, attraverso l’espediente della lettura critica di un progetto costruito, approfondire in particolare una questione: il rapporto che l’architettura può stabilire con l’arte.
La tesi che qui si vuole sostenere è infatti quella secondo cui è possibile leggere il progetto di questo edificio attraverso l’individuazione di una serie di problemi usuali del progetto d’architettura come il rapporto con la città o la destinazione funzionale e il loro successivo confronto con operazioni tipiche delle arti figurative come l’astrazione o la materia, per arrivare al riconoscimento delle nuove soluzioni cui il progettista è pervenuto proprio dal proficuo confronto tra arte e architettura.
A questo scopo la lettura analitica dell’opera procederà secondo due ordini di questioni: da un lato la lettura formale dell’opera mediante l’individuazione di alcuni dei concetti che la ordinano; dall’altro la comprensione concreta delle modalità di trasferimento di un concetto artistico nel progetto d’architettura.
Critica
Ci sono almeno tre critici d’arte che mi sono serviti per impostare il modo di guardare a quest’opera. E il legame tra loro è dato dal fatto che ognuno di essi introduce con forza il ruolo dell’osservatore nell’atto critico, impone cioè come prioritario il problema del punto di vista di chi osserva – che per noi significa anche di chi osserva per poi fare. Sono tutti autori che mettono in evidenza la “crepa che si apre tra opera e osservatore”[1].
Mi riferisco in primo luogo ai lavori di Michael Baxandall, quando descrive in modo così schietto e preciso il suo lavoro di critico:
“Della critica, quindi, il libro affronta un solo aspetto: la tendenza del nostro pensiero, applicato ai quadri come ad altre cose, a inferire delle cause. […] nella possibilità di verificare posizioni molto semplici rispetto a casi complessi.”[2]
“Se vogliamo spiegare un quadro, lo spiegheremo come considerato dal punto di vista di una sua descrizione parzialmente interpretativa. La descrizione non è tanto la rappresentazione del quadro, e neppure la rappresentazione dell’esperienza della visione del quadro, quanto piuttosto una rappresentazione di quanto si è pensato dall’osservare il quadro. In altre parole, noi descriviamo una relazione tra quadro e concetti, andiamo e veniamo tra immagini e parole.”[3]
“Se l’osservatore appartiene ad una cultura diversa […] è probabile che interpreti nei termini di ‘soluzione di un problema’ quello che per l’autore è stato un modo di procedere nella norma della cultura di appartenenza. […] L’osservatore insomma impone un modello formale all’interpretazione dell’oggetto che stimola il suo interesse critico.”[4]
“Non parliamo dell’intenzione sotto forma di narrazione di ciò che realmente accadde nell’animo del pittore, ma creiamo un complesso analitico relativo ai suoi scopi e ai suoi mezzi, limitatamente a come li deduciamo dalla relazione che l’oggetto [il quadro] ebbe con circostanze identificabili; il tutto in una relazione ostensiva con il quadro.”[5]
Ancor più strumentali al nostro lavoro sono le pagine in cui Baxandall descrive e approfondisce l’analogia tra scrittura e pittura nell’opera di Leon Battista Alberti, confrontata con la retorica di Cicerone.[6]
Un’altra grande apertura è data dagli scritti di John Berger. La lettura di testi come Sul guardare o di Sacche di resistenza ci offre gli strumenti per lavorare sul soggetto tramite associazioni. Un simile dispositivo mentale ci permette di andare oltre, di lasciar affiorare comunque la condizione umana in cui si è operato, di valorizzare “la consapevolezza che l’esperienza soggettiva è un fattore storico importante.”[7] Si indaga sul guardare attraverso il tempo e lo spazio di chi opera e di chi osserva:
“Queste fotografie entrano a tal punto nel particolare da rilevarci l’intero corso di una cultura o di una storia che, come sangue, fluisce attraverso quel dettaglio. [Paul Strand] trasforma i suoi soggetti in narratori […] tale contesto ricolloca la foto nel tempo – non nel suo tempo originario, perché è impossibile – ma nel tempo narrato. Il tempo narrato diventa tempo storico quando è assunto dalla memoria sociale e dall’azione sociale. È necessario che il tempo costruito e narrato rispetti il processo della memoria che spera di stimolare.”[8]
“L’assenza di alternativa, nella sua visione della condizione umana si riflette nell’assenza di qualsiasi sviluppo tematico nell’insieme della sua opera […] non esiste niente altro.”[9]
“Una volta ho sognato di essere uno strano tipo di commerciante: un commerciante che trafficava in apparenze o sembianze. Le collezionavo e le distribuivo. Nel sogno avevo scoperto un segreto. Il segreto consisteva nell’entrare dentro alle cose che avevo davanti agli occhi (un secchio d’acqua, una mucca, una città come Toledo vista dall’alto, una quercia) e una volta all’interno aggiustare le loro apparenze esterne nel modo migliore. Nel modo migliore non voleva dire renderle più belle o più armoniose: non voleva neanche dire renderle più tipiche, in modo che una quercia potesse rappresentare tutte le querce possibili; voleva dire renderle più se stesse, in modo che la vacca o la città o il secchio diventassero oggetti unici in modo più evidente. Il segreto per entrare in un oggetto e risistemare il suo modo di apparire era semplice quanto aprire la porta di un armadio. Forse era solo questione di trovarsi al posto giusto quando la porta dell’armadio si spalancava da sola.”[10]
Il lavoro di Rosalind Krauss è ancora più sofisticato: cerca di assoggettare un’opera a un concetto altro, anche se non immediatamente collegato. Sceglie in un periodo storico, o in un altro ambito di interesse, i criteri che si rivelano poi utili alla decifrazione dell’opera.
“L’informe, dicevamo più sopra, designa qui un insieme di operazioni con cui il modernismo è preso in contropelo. […] Si può considerare l’informe come puro oggetto di una ricerca storica, ma questo approccio comporta il rischio di trasformare l’informe in una figura, di stabilizzarlo.”[11]
Con queste citazioni si vuole mettere in evidenza come, in questi casi, la critica proceda innanzitutto attraverso l’individuazione di alcuni concetti, e, successivamente, sulla riflessione circa il modo più adeguato di usarli, non come oggetti, ma come operazioni.
In architettura potremmo citare la ricerca di Bruno Reichlin sulla tettonica, dove gli esempi sono forzati alla dimostrazione della sua teoria o lo studio di Gillermo Zuaznabar su Donald Judd[12], dove il limite, cassa o frontiera, contenitore o come dir si voglia, diventa concetto per analizzare opere, più che autori, lontanissimi tra loro.
Per leggere l’edificio del Gobierno Civil di Tarragona di Alejandro de la Sota abbiamo a disposizione anche altri strumenti critici, a cominciare dalle numerose testimonianze che lo stesso Alejandro de la Sota ci ha lasciato sulla propria consapevolezza progettuale. Abbiamo infatti a disposizione i suoi scritti e le sue conferenze, ma anche gli articoli di quelli che con lui hanno lavorato: Juan Navarro Baldeweg, José Manuel López-Peláez, Pepe Llinás. De la Sota era solito accompagnare le sue lezioni con una serie di immagini di oggetti di diversa natura a cui lui associava concetti d’architettura[13].
“Fare architettura è un processo mentale, trovare una soluzione chiara per risolvere un problema posto. Ho spesso comparato il costruire una planimetria architettonica con il gioco degli scacchi ad occhi chiusi: non c’è possibilità. Se tocchi il pezzo, lo hai mosso. Noi siamo bendati, e tutti i dati che riceviamo devono essere elaborati dalla mente (che aggiunge sempre qualche cosa) mentre passiamo in rassegna tutte le possibili combinazioni che possono essere usate per trovare una soluzione corretta.”[14]
Lo stesso de la Sota parla della scelta di tutti gli elementi che possono trovarsi all’interno della mente nella fase del progetto; parla dei materiali e della loro unità: “tutti i dati rendono un’opera come inevitabile” spiega, ma poi aggiunge anche, con la metafora degli occhi bendati, come il percorso su cui si procede non possa essere razionale, logico e descrivibile nella sua interezza, come ci ricorda José Manuel López-Peláez nel suo articolo sulle caricature.[15]
In questo percorso si è cercato poi di seguire anche Pepe Llinás, che con Alejandro de la Sota ha lavorato al progetto di restauro dell’edificio del Gobierno Civil negli anni ottanta, quando dice, nell’introduzione ai testi di de la Sota, che “quello che mostrano questi scritti potrebbe esser stato l’origine dell’opera e, al contrario, che il pensiero che accompagna il progetto e l’opera può avere dato origine al testo.”[16] In altre parole, è lo stesso de la Sota a suggerire ai critici di procedere alla lettura del suo lavoro confrontando i problemi concreti del progetto con le riflessioni artistiche introdotte dagli scritti.
Se si pensa al carattere concettuale dell’arte moderna, al fatto che ogni opera richieda al suo pubblico non uno sguardo passivo, ma un’interpretazione attiva tanto del processo di elaborazione quanto del significato finale dell’opera, diventa allora possibile seguire i percorsi di ricerca che l’analisi ci suggerisce attraverso l’individuazione di alcuni concetti chiave, e in particolare quelli di astrazione o di materia.
I problemi del progetto
Il Palazzo del Gobierno Civil è un progetto di concorso vinto da de la Sota nel 1957 e successivamente realizzato nella parte nuova di Tarragona, antica città di origini romane. L’edificio si attesta su una piazza circolare di recente realizzazione, il cui disegno viene subito criticato dall’architetto. Successivamente, parlando della scelta della pietra di rivestimento, de la Sota introduce il forte legame con la città antica. Il confronto con la città si sdoppia quindi in un rifiuto del contesto reale a favore dell’antica città romana.
Anche la destinazione funzionale viene esplicitamente espressa dall’architetto come uno dei problemi del progetto. L’edificio è infatti la sede del Gobierno Civil, definiamolo pure il palazzo del Governatore, istituzione di massimo controllo sulla città, a maggior ragione nella Spagna franchista del 1957.
La sua funzione era duplice: da un lato ospitare gli uffici veri e propri del Gobierno Civil, dall’altro accogliere le residenze del governatore, del segretario e di eventuali ospiti. Per questo motivo il volume è stato spaccato in due fin dai primi studi, prima verticalmente e poi orizzontalmente. De la Sota esprime già nella relazione di progetto la lotta con l’ambiguità della destinazione d’uso.[17]
Tra gli schizzi di studio volumetrico dell’edificio si può notare il ridisegno della torre per uffici Johnson di Wright, dove la sezione si sviluppa inotrno al vuoto creato dall’arretramento dei pilastri: de la Sota studia i maestri del moderno, ma li astrae attraverso un problema tecnico, fino a fargli perdere riconoscibilità. Il tema dell’arretramento dei solai infatti si trasforma da sezione in facciata principale.
La facciata è il luogo dove si concentrano e prendono forma i problemi che la città e la funzione pongono al progetto.
Questa ci appare spesso in una fotografia in bianco e nero, quasi un’astrazione dei suoi pieni e dei suoi vuoti, della loro semplificazione in quadrati neri e della loro composizione sul piano bianco. È una facciata dove il volume cubico in pietra si appoggia sul vuoto del piano terra, scandito da quattro pilastri in ferro disposti lungo l’impercettibile arco del cerchio della piazza, una facciata dove balconi e logge sono ridotti a tagli e scavi nella pietra. La linea nera orizzontale, corrispondente alla loggia del secondo piano, sembra appoggiarsi solo sul vuoto del balcone centrale. Nella parte superiore, le logge quadrate, sfalsate, si equilibrano nel disegno del fronte, senza esprimere nulla di ciò che trova posto al suo interno.
All’ultimo piano, una casa a patio centrale, appoggiata sul tetto, si rende quasi invisibile; si tratta di una piccola villa arretrata rispetto al volume cubico che riassume l’intero edificio.
Astrazione e materia in architettura
Possiamo ipotizzare che Alejandro de la Sota sperimenti e trovi in alcuni concetti dell’arte moderna la soluzione ai problemi del progetto?
Tra i suoi scritti e le sue conferenze è facile rintracciare una linea che si muove all’interno dell’arte astratta, da Paul Klee a Josef Albers, ai lavori della Bauhaus.
“Ispirazioni. Lo dico con tutta umiltà: cerco sempre ispirazioni architettoniche molto lontano da me, molto lontano dall’architetto. Non mi piacciono i libri d’architettura. Non mi piace mai pensare che è uscito qualcosa d’importante, per me, di architettura, che non sia stato motivato da molto lontano. […] cose che mi hanno mosso ad una comprensione, ad una vibrazione che è stata usata.”[18]
Può risultare utile ricordare un aneddoto che de la Sota citava spesso:
“Ho avuto una crisi dopo la laurea. Ho avuto la fortuna di avere la forza sufficiente di non lavorare. […] la novità arrivò nel modo più semplice. Fu un libro di Marcel Breuer che si chiama Sun and Shadow. Quel libro parlava di come proteggere le finestre […] gli uscivano sculture senza essere scultore.”[19]
De la Sota riconosce a Breuer il merito di aver espresso chiaramente nel testo, che accompagna le sue opere, quell’idea dell’unità dei contrasti che già il titolo annunciava. Ma c’è anche un filo diretto che lega Breuer, e il suo Sun and Shadow al fronte del palazzo di Tarragona e questo filo passa attraverso Semper e la sua idea della facciata come rivestimento, opera di arte tessile[20].
De la Sota era anche solito citare Josef Albers. Ci sono diversi temi del lavoro di Albers che rintracciamo nella sperimentazione progettuale di de la Sota: l’arte tessile appunto, ma anche il lavoro sui materiali e il tema del quadrato, sottoposto in diversi modi al concetto di forma positiva e di forma negativa.
Uno dei massimi insegnamenti di Albers era proprio il riconoscimento e il conseguente uso corretto dei materiali: “La forma dipende dal materiale con cui lavoriamo.”[21]
Il corrimano della scala principale del palazzo del Governatore, piegato per conferire maggior resistenza del materiale, sembra realizzato in un’aula dei laboratori della Bauhaus, dove Albers teneva il corso propedeutico.
“Ho visto con chiarezza come loro [Gropius e Breuer] usavano i nuovi materiali e come arrivarono ad un’architettura che io nominai FISICA, fisica intesa nel senso dell’unione di elementi differenti allo scopo di ottenere un terzo elemento che, senza perdere nessuna delle proprietà dei suoi elementi costituenti, contenga anche qualcosa di più, qualcosa di nuovo.”[22]
Molti critici hanno sottolineato l’importanza dell’uso dei materiali nell’architettura di de la Sota, peraltro chiaro nelle sue stesse parole: “Mi immagino quanto ci farebbe bene stare seduti otto, dieci giorni sopra un blocco di granito che stiamo per usare per quell’opera; starcene quindici giorni contemplando il cemento dentro la betoniera, a vedere i chilometri di laminati di profili […], piccoli esercizi spirituali.”[23]
Non a caso parla del blocco di granito: de la Sota è originario della Gallizia, dove tutto è costruito in granito. Il suo modo di lavorare non procede per questioni squisitamente compositive, ma per materiali.
Nella scelta dei materiali per il palazzo del Governatore emerge la volontà di rapportarsi all’antica città romana di Tarragona proprio usando la materialità della pietra. “La pietra è, con il legno, l’unico materiale che la natura ci fornisce prefabbricato, tutto il resto è ‘chimico’…”[24]
La città romana con cui de la Sota sceglie di confrontarsi è quella che permane nell’immagine della città. I riferimenti non sono tanto i bei monumenti, come ad esempio l’arena, quanto piuttosto le grandi costruzioni in pietra, l’acquedotto, la muraglia e il pretorio. Il suo rapporto con la città romana è sovrastorico, del tutto materiale. La pietra, la materia dell’antica città romana, viene utilizzata per rafforzare le bucature astratte della facciata del palazzo. Una facciata tridimensionale che si contrappone ai fronti laterali, dove invece vetri e lastre di marmo hanno entrambi uno spessore esiguo che rende esplicita la loro funzione di rivestimento: materia scavata e tridimensionale, a discapito della rappresentatività del piano/facciata tipica del palazzo.
Se nella facciata principale Alejandro de la Sota mette in dubbio il disegno bidimensionale della facciata classica, sui fronti laterali invece inizia un altro tipo di processo di astrazione che avrà grande sviluppo nella sua opera successiva. Possiamo quasi pensare che il rivestimento in marmo, così leggero, riesca solo in parte a coprire un tema tanto caro all’architetto: la scatola di vetro, qua ancora nascosta, si esprimerà poi in alcuni progetti importanti, come ad esempio quello per l’Aviaco.
Juan Navarro Baldeweg, pittore e architetto che ha disegnato lo scudo in bronzo[25] usato da de la Sota per riequilibrare la composizione del fronte, ha scritto un articolo puntuale, come solo un artista che opera sa fare, sull’astrazione in Alejandro de la Sota[26]; in esso spiega la differenza tra l’astrattismo geometrico di un Terragni e quello immediato, materiale, riscontrabile invece nel Gobierno Civil, che Baldeweg riconduce a Malevic[27].
Il progetto per il palazzo del Governatore viene presentato nel 1957, anno in cui lo scultore basco Jorge Oteiza decide di sospendere la sua opera di scultore e di interrompere il suo proposito sperimentale.
Alejandro de la Sota si era già interessato a Oteiza in un articolo sul progetto di Saenz de Oiza per una cappella sul cammino di Santiago:
“La pietra in forma infantile, e per questo chiamano Oteiza, quasi infantile nella sua persona, per la sua perfezione.
[…] è necessario pensare con i metalli, anche quando usiamo le pietre; le useremo in modo molto più puro, più nobile; contrasto tra massiccio, pesantezza e fragilità, leggerezza.
La riuscita impressionante di questo progetto, per me, è il modo profondo in cui sono trattati idea e materiali […]. La pietra, usata come bambini, il metallo, come ingegneri puri; il tutto unito, lo ripeto, da degli artisti.”[28]
Il proposito sperimentale dello scultore Oteiza era tutto incentrato sullo svuotamento della materia. Dis-occupazione del cubo, del cilindro, della sfera.
Il suo continuo riferimento all’arte astratta delle Avanguardie avviene tramite Malevic, con la creazione di una figura spaziale vuota, infinita, dentro una cornice. Tutte le sculture di Oteiza sullo svuotamento del cubo rappresentano la definizione dei confini di un possibile spazio, di un vuoto predisposto ad accogliere[29], così come gli infiniti pezzi del Laboratorio de Tizas esprimono il tentativo di rappresentare volumetricamente questa spazialità.
Oteiza è anche scrittore, di poesie, di arte e di saggistica in lingua basca. Nel suo libro teorico forse più famoso, Quousque Tandem…!, ci racconta della sua infanzia:
“Molto piccolo, a Orio, mio nonno mi portava a passeggiare sulla spiaggia. Io ero attratto da dei grandi buchi che si trovavano nella parte interna. Mi nascondevo lì dentro, sdraiato, guardando il grande spazio del cielo. […] Permettetemi un altro ricordo personale dell’infanzia, della cava dove giocavo con mio cugino. L’indimenticabile soddisfazione, che apparve nella cava, di perforare la pietra: scoprire l’altro estremo libero del foro. La mia attività consisteva nel fare buchi in tutte le pietre che potevo.
Solo ora posso associare e spiegarmi tutti questi ricordi. Mettere insieme la mia contemplazione del cielo lontano, dal fondo del mio buco nella sabbia della spiaggia, con il fabbricare il piccolo vuoto, spiritualmente respirabile e liberatore, del foro, a portata di mano, della pietra. Se come scultore non avessi concluso la mia attività sperimentale in un solo e semplice spazio vuoto, avrei dimenticato questi ricordi.”[30]
De la Sota guarda i grandi scavi nella materia della città romana dallo stesso punto di vista. De la Sota sembra interporre tra lui e la città lo svuotare di Oteiza. Prende a prestito da entrambi la capacità di astrarre le questioni, di lavorare per sottrazioni, come la proposta per un’estetica negativa che Oteiza aveva teorizzato: “una serie progressiva di eliminazioni fenomenologiche, riducendo tra parentesi tutto quello che dobbiamo eliminare per isolare l’oggetto vero.”[31] Ma l’analisi dell’opera scultorea di Oteiza ci fornisce altre indicazioni preziose: in occasione di una esposizione a San Paolo, Oteiza produce dei modelli in vetro dove sperimenta la luce filtrata attraverso la sovrapposizione di più piani trasparenti, le pareti-luce. Anche nel caso della realizzazione del palazzo, la facciata diventa tridimensionale e le logge si trasformano in scatole di luce realizzate in vetro, scavate all’interno dell’appartamento.[32]
Lo stesso de la Sota, ricordava José Manuel López-Peláez, discutendo del suo modo di progettare era solito parlare del togliere il peso.
De la Sota era solito citare Klee a dimostrazione dei suoi principi compositivi. In particolare, l’immagine più usata era il quadro Case di vetro[33], così commentato: “Un’ispirazione favolosa, la cosa che non pesa, che non si sa come si allaccia, ma ha un suo ordine; è così. La vibrazione è permanente quando uno è impegnato nel fare qualcosa.”[34]
Ripartiamo quindi dal confronto tra un quadro di Klee e la facciata del Palazzo[35]. L’analogia formale è immediata, ma possiamo individuare i principi che si ritrovano nel disegno del fronte del palazzo del Governatore anche tra le pagine scritte della Teoria della Forma e della Figurazione di Klee.
Nel secondo capitolo degli Schizzi Pedagogici, dopo aver definito il senso delle dimensioni, Klee affronta il tema dell’equilibrio, arrivando a esemplificarlo con una teoria di pietre sovrapposte a costituire una torre.
Analogamente, mettendo in equilibrio i due balconi, è come se de la Sota esprimesse il suo dubbio sul progetto e sulla sua destinazione funzionale, mettendo in mostra la loro crisi: introduce, sul fronte principale, prima l’equilibrio e il peso delle forme, ma poi il loro disassamento.
De la Sota nasconde le due diverse funzioni, ma anche l’impegnativa rappresentatività del palazzo, e nello stesso tempo dichiara la sua adesione all’architettura moderna, attraverso l’astrazione delle forme. I principi dell’arte moderna sono portati in facciata: linea e chiaroscuro sono infatti i mezzi plastici primordiali.[36]
Ma un ulteriore concetto attraversa l’esperienza dell’arte moderna e le pagine del trattato di Klee: il movimento, che nella facciata del palazzo si realizza nel disequilibrio delle logge.
“Qualsiasi cosa in divenire riposa sul movimento. Nel Laoconte, Lessing dà grande rilievo alla differenza tra arte del tempo e arte dello spazio. Ma anche lo spazio è una nozione temporale. Il fattore tempo interviene nel momento in cui un punto entra in movimento e diventa linea. Allo stesso modo, una linea muovendosi genererà una superficie; e così ancora per il movimento che conduce da superfici a spazi.”[37]
Il vuoto come unità di contrasti
Luce, equilibrio, gravità sono i temi fondamentali della composizione scultorea, pittorica e architettonica di Juan Navarro Baldeweg. Lasciamoci quindi guidare ancora dalle sue parole per sviluppare un ultimo aspetto del progetto del palazzo del Governatore. Navarro Baldeweg, nella descrizione di un altro progetto di de la Sota per Alcudia, riesce a individuare una questione fondamentale, quella che lega il vuoto all’unità dei contrasti.
“I disegni mostrano una capacità artistica invidiabile di assemblare cose distanti in un unico impulso. Tutto sembra restar definito tra estremi, coprendo distanze in un’oscillazione di osservazioni […].
Questi disegni mostrano la schiva magia artistica dell’opera di Alejandro de la Sota. Tutto è trasparente e esplicito e, nonostante tutto, qui l’architettura si ritira, si occulta, si fa quasi opaca… Questa enigmatica espropriazione, questa paradossale trasparente opacità (…) si rinuncia alla ossessione della materialità per quasi non essere.
[…] Questa manifestazione della vita concreta è ben lungi dall’esser banale. I disegni emozionano per la capacità di fondere il necessario ed il contingente, il vicino e il lontano, quello che è immobile e quello che si muove a differenti scale, situazioni e ritmi.”[38]
Quell’unità di contrasti, che abbiamo visto affiorare qua e là come tema nel corso di questa analisi, è un riferimento esplicito a Breuer e una costante nella costruzione dell’edificio, dove la luce interna si contrappone ai buchi neri, dove le masse buie dell’esterno si trasformano in scatole di luce.
Possiamo individuare con precisione almeno tre soluzioni architettoniche di realizzazione di questo vuoto, oltre ai balconi già descritti. Intanto la villa a patio centrale che de la Sota realizza sulla copertura dell’edificio, con la sua planimetria introversa; il vuoto rappresentativo del secondo piano dove il soffitto si trasforma in una macchina di luce e tutti gli elementi che lo definiscono sembrano fluttuarvi, predisposti alla realizzazione di questo spazio.[39] Infine il vuoto dello spazio pubblico al piano terra, la vera piazza coperta che de la Sota contrappone alla banalità della piazza disegnata dalla speculazione, dove vengono collocati solo i pesanti elementi in marmo, il bancone del portiere e le panchine del nuovo spazio pubblico, che appaiono adagiati a terra con una modalità molto vicina ai lavori contemporanei dell’arte minimalista.
Non è più il momento di aprire altri confronti, ma di chiudere ricordando la consuetudine dell’architettura spagnola a guardare all’architettura nordica, E che cosa non è tutta l’opera successiva di de la Sota se non la verifica strutturale, tecnica e spaziale di questo vuoto?
[1] Josep Quetglas, Note di lettura al corso di Dottorato, dattiloscritto, Barcellona 2002, p. 3. Trad.d.A.
[2] Micheal Baxandall, Forme dell’intenzione, Torino 2000, p. 7.
[3] Ibidem, p. 24.
[4] Ibidem, p. 103.
[5] Ibidem, p. 160.
[6] Micheal Baxandall, Giotto e gli umanisti, Milano 1994, pp. 172-174.
[7] John Berger, Un articolo di fede, in Sul guardare, Milano 2003, p. 140.
[8] John Berger, Paul Strand, in Sul… cit, pp. 48-68.
[9] John Berger, Francis Bacon e Walt Disney, in Sul… cit, p. 131.
[10] John Berger, Passi verso una piccola teoria del visibile, in Sacche di resistenza, Milano 2003, p. 15.
[11] Yve-Alain Bois, Rosalind Krauss, L’informe. Istruzioni per l’uso, Milano 2002, p. 13.
[12] Gillermo Zuaznabar, S/T. Donald Judd; pabellones de artilleria, Marfa, Tx. 1979-94, Tesi di dottorato svolta presso la Escuela de Arquitectura de Barcelona, direttore Josep Quetglas, Barcellona 2003.
[13] “1. La lampadina. Il massimo rendimento con il minor materiale, con il meno possibile. Il vuoto realizzato con una pellicola finissima di vetro rivoluzionò il nostro mondo. 2. Paul Klee. Le trasparenze. Suggerire l’immateriale. Definire i limiti di un territorio. Delimitare. 3. Balenciaga. Il mondo della moda, eleganza, stravaganza. Si dice: “Il dettato della moda” e “la volontà di stile”. 4. Mirò. Il colore, il vuoto, senza trucchi. La vibrazione interiore. 5. Gli aerei. La tecnologia più perfetta. Il più leggero è anche il più forte e resistente. Cos’è l’architettura di fronte a questo? 6. Il fascio di rotaie. Come molte cose nella vita per un istante tutto appare confuso, come una ragnatela di rotaie senza senso apparente. Ciononostante, i binari seguono le loro leggi: a coppie, con un raggio di curvatura preciso, combinato dall’incrocio di dimensioni e tangenze conosciute, con una precisa geometria, che alla fine manifesta il suo ordine nel mare di rotaie di una grande estensione. L’ordine essenziale. 7. Il canale. Bisogna osservare come l’ingegneria risolve i problemi. Se bisogna realizzare un’opera, si progetta la macchina che produce l’opera. Questo è il senso ultimo della prefabbricazione. 8. Cooperativa. Anche la luce nella Cooperativa de Haag, Buijs, e Lürsen. 9. Albers. L’ordine figurativo, l’essenza che sorge dal piano (pianta).” Tratto da Ismael Guarner, Intorno ad alcune diapositive delle conferenze di Alejandro de la Sota, in «Bau», n. 013. Trad.d.A.
[14] Alejandro de la Sota, Memorie e esperienze, in Alejandro de la Sota, Madrid 1989, p. 17. Trad.d.A.
[15] “Nell’archivio di don Alejandro sono conservate centinaia di queste caricature, alcune sono state pubblicate ed hanno raggiunto una certa popolarità. Non c’è dubbio che manifestino la facilità d’uso dei tratti grafici, non solo per mostrare le idee, quanto piuttosto come un vero strumento di dialogo tra attività mentale e la sua concretezza fisica. […] non si tratta tanto di deformare la realtà, quanto di interrogarla con intelligenza e guardarla da un altro punto di vista, che possa risultare sorprendente.” José Manuel Lopez-Pelaez, Caricaturas, in «Circo», n. 26, 1995. Trad.d.A.
[16] Josep Llinás, Introduzione, in Alejandro de la Sota. Escritos, conversaciones, conferencias, a cura di Moisés Puente, Barcelona 2002, p. 11. Trad.d.A.
[17] “Si è lottato con la grande difficoltà di comporre un blocco armonico, gerarchico e nobile, poiché entravano nella composizione, obbligatoriamente, uffici e sale di rappresentanza, insieme a case d’abitazione, tutto nelle stesse facciate. Si pensa di aver conseguito un insieme armonico grazie al modo di trattare le bucature, le luci, le terrazze delle abitazioni che, senza nulla togliere dell’efficacia in quanto a luce e aria, risolve plasticamente il problema, facendo perdere alle residenze quell’aria da condominio che hanno di solito. Le logge della facciata principale, che corrispondono agli appartamenti, si sono mosse in modo tale da rompere quell’asse definito, che altrimenti avrebbero segnato con forza; questa rottura è giocata in modo tale che, introducendo altri elementi come scudo, bandiera, panca, etc. nella composizione, questa non si perda e che quest’equilibrio della facciata possa essere tale, ma che si possa anche dire dinamico o potenziale, non statico, con minore intenzione e emozione; si pensa che questo abbia un certo valore nella composizione.
Anche nelle facciate laterali si è giocato con una certa novità nelle bucature, trattandoli con libertà in quanto a assi e altezze, rompendo un’ulteriore lancia contro la schiavitù o tirannia delle finestre nella composizione degli edifici. Non si pensa di aver rovinato o perso la nobiltà dell’edificio, anzi di averla aumentata, ovviamente in quanto a sobrietà.” in «R.N.A.», n. 185, maggio 1957.
[18] Alejandro de la Sota, Conferenza a Barcellona, gennaio 1980, in Alejandro de la Sota… cit, p. 178. Trad.d.A.
[19] Alejandro de la Sota, Conferenza a Barcellona, gennaio 1980, in Alejandro de la Sota… cit, p. 171. Trad.d.A.
[20] “Breuer usa i materiali come la pietra o il cipresso, ma li lavora con principi senza stile, che comprende e approfondisce. Senza di questo i materiali sarebbero privi di significato, apparterrebbero alla natura e non alla cultura. […] Nelle case di Breuer, la muratura in pietra solo in poche occasioni è caricata di peso, molte volte riveste un muro di cemento, altre semplicemente chiude; in ogni caso, questa tecnica è scelta in primo luogo per i suoi valori astratti, per la sua capacità di contrasto e relazione, come equivalente visivo dell’ombra. Un artigiano come Breuer sa alla perfezione che i termini duttilità e malleabilità non descrivono qualità materiali delle cose, bensì qualità formali delle materie: duttile è un materiale che può essere ridotto a linee, malleabile quello che può essere convertito in lamine; questo potrebbe essere il punto di contatto tra artigiani e artisti nella Bauhaus. Linee e piani sono elementi della costruzione assiomatica del mondo, comuni all’arte tessile, alla definizione semperiana della tettonica e alla ricerca delle ragioni formali della natura nell’opera di Klee e Kandinsky.” Tratto da Antonio Armesto, Quince casas americanas de Marcel Breuer (1938-1965). La refundación del universo doméstico como propósito experimental, in «2G. Marcel Breuer», n. 17, giugno 2001, Trad.d.A.
[21] “Josef Albers”, in Magdalena Droste, Bauhaus 1919-1933, Colonia 1998, p. 141.
[22] Alejandro de la Sota, Memorie e esperienze, in Alejandro de la Sota… cit, p. 16. Trad.d.A. Paul Klee l’aveva espresso con queste parole: “Gli elementi devono produrre le forme, ma senza sacrificarvi la loro integrità. Mantenendo la loro identità.” tratto da Paul Klee, Teorie … cit, p. 36.
[23] Alejandro de la Sota, Alumnos de Arquitectura, in «Arquitectura», n. 9, settembre1959, p. 3. Trad.d.A.
[24] Ibidem, p. 80. Trad.d.A.
[25] Ho avuto occasione di intervistare Juan Navarro Baldeweg sul periodo di apprendistato presso lo studio di de la Sota, avvenuto nel periodo di costruzione del Palazzo; Navarro Baldeweg ricordava che per de la Sota era molto importante che quel bronzo fosse come una vecchia moneta, dove i tratti non sono quasi più percepibili, se non al tatto.
[26] “Una norma interna caratterizza fuor di misura ogni progetto. Vi è un procedere di ragionamento secondo un’esigente progressione riflessiva che si da quasi come manifesto già nel progetto per il Governo Civil di Tarragona. La volontà di astrazione porta le cose fino ad un punto in cui cessano di esserlo, trasformate in principio, convertite, attraverso un processo alchemico in scoglio puro. Ed è, certamente, un residuo già ripulito di ogni scoria, quello che possiamo mettere in parallelo all’anima dell’alzato del Gobierno Civil con la piazza nella quale è collocato. L’edificio potrebbe rimandarci a Terragni, però subito ci allontaniamo da questo grande ricordo.
Notare la differenza nell’uso dell’astrazione è, a volte, avvicinarsi alla comprensione della sua singolarità. Qua siamo lontani da una complessità astratta nata da una laboriosa genesi plastica. La semplicità dell’astrazione che presenta il Gobierno Civil è diretta, corrisponde ad un’immagine formulata in un sol colpo, è un’apparizione veloce più vicina a Malevič che a Mondrian. Incontreremo difficilmente nell’architettura contemporanea un oggetto tanto iconicamente precisato, tanto ipnotico. E’ una figura di presenza come tre note di timpano suscitate dall’incontro spontaneo con il nostro guardare.” tratto da Juan Navarro Baldeweg, Una laboriosa abstracción, in «Arquitectura Viva», n. 3, novembre 1988, p. 29-31.
[27] “Il sentimento intuitivo ha trovato una nuova bellezza negli oggetti – l’energia delle dissonanze che risulta dall’incontro di due forme.” Kazimir Malevic, De Cezanne au suprematisme, Losanna 1974, p. 41.
[28] Alejandro de la Sota, Una capilla en el camino de Santiago, in «R.N.A.», n. 161, maggio 1955. Trad.d.A.
[29] Carlos Martí Arís, Silenzi eloquenti, a cura di Simona Pierini, Milano 2002, p. 105.
[30] Jorge Oteiza, Quousque tandem…! Ensayo de interpretacion estetica del alma vasca, Pamplona 1963, n. 75 (Oteiza non accetta la numerazione delle pagine). Trad.d.A.
[31] Ibidem, n. 63
[32] “Anche la luce, l’idea di illuminare in profondità, in sezione, è materia trattata da Jacobsen in modo molto affascinante.” tratto da Intervista sull’opera di Arne Jacobsen, in Alejandro de la Sota… cit, p. 121. Trad.d.A.
[33] De la Sota ha usato questa stessa pittura anche per spiegare il suo progetto per il nuovo palazzo in vetro dell’Aviaco.
[34] Alejandro de la Sota, Conferenza a Barcellona, gennaio 1980, in Alejandro de la Sota… cit, p. 178. Trad.d.A.
[35] Juan Antonio Cortés, Lecciones de equilibrio, in «Anales de Arquitectura», n. 6, 1998, p. 180-183.
Recentemente, successivamente alla stesura di questo mio testo, Cortés ha pubblicato un approfondito volume monografico sull’edificio; vedi Juan Antonio Cortés, Gobierno Civil de Tarragona, 1957-1964, Almeria 2006.
[36] “ Il primo di questi mezzi è la linea, questione di misura solamente. […] Di altra natura sono le tonalità o valori del chiaro scuro: le numerose gradazioni tra bianco e nero. Questo secondo elemento concerne questioni di peso. […] il disegno è l’arte d’eliminare.” tratto da Paul Klee, Teorie de l’art moderne, Berna 1956, pp. 19-21. Trad.d.A.
[37] Paul Klee, Teorie … cit, p. 37. Trad.d.A.
[38] Juan Navarro Baldeweg, Construir y habitar, in «AV monografías», n° 68, novembre-dicembre 1997, p. 30. Trad.d.A.
[39] Pepe Llinás, parlando degli interni del Palazzo, ci fa notare che i tavolati non appoggiano a terra: “Le divisioni non sono soggette a nessun sistema formale. Ballano sulla superficie della pianta: non c’è zoccolo e, quindi, la base della parete non è stretta dalle rotaie che si sollevano dal pavimento. Le porte sono come pareti. Le porte, un volume (non un piano) dello stesso spessore delle pareti.” in Josep Llinás, El Gobierno Civil de Tarragona, in Saques de esquina, Valencia 2002, p. 86. Trad.d.A.
CASE STUDIES
HOUSING PRIMER
Primer, l’abecedario utilizzato nelle scuole primarie inglesi, è il titolo che Alison Smithson diede alla raccolta dei saggi del Team 10. Se l’edificio pubblico e il suo
carattere oggettuale hanno caratterizzato il recente lavoro delle archistar, è in realtà nel lavoro costante sulla residenza che le recenti esperienze europee hanno saputo declinare con ampio respiro un programma urbano concreto e ricco di significato. Vogliamo dunque riprendere oggi quello stesso titolo con l’intenzione di proporre una lettura critica della produzione architettonica residenziale più recente, con l’ambizione di proporre chiavi interpretative a partire da tematiche propriamente urbane.
A differenza del metodo di classificazione puramente accumulativo espresso da molta manualistica contemporanea, che vede nella casistica una risposta alla complessità del reale, il nostro lavoro si prefigge di verificare se e come tali esperienze recenti possano essere ricondotte ad un numero limitato di principi, sia insediativi che morfologici, sia sociali che tipologici, se esse continuino consapevolmente a fare città e quali strategie progettuali vengano messe in atto a questo fine. Escludendo cioè di rassegnarsi alla pura forza evocativa del singolo intervento, si propone di verificare le possibilità di un rinnovato legame tra sperimentazione architettonica e realtà urbana. Il lavoro di ricerca è stato impostato a partire dalla schedatura di 200 case studies, le planimetrie dei
quali compongono l’Atlante Urbano della Residenza che conclude il volume.
La prima parte del volume affronta i caratteri dell’urbanità nel linguaggio dell’architettura della casa, con uno sguardo che cerca di metterne a fuoco gli strumenti interpretativi e progettuali. Le variazioni di scala, il ritorno alla scacchiera urbana, una certa disinvoltura tipologica, la ricerca dell’altezza giusta, ma anche le declinazioni della domesticità nella disposizione urbana e nei caratteri costruttivi, identificati nella produzione contemporanea, diventano i ferri del mestiere per un lavoro di progettazione spesso ispirato, nonostante le apparenze, a un senso di continuità e a un uso concreto dell’esperienza storica.
La seconda parte del volume affronta invece la questione dal punto di vista dell’abitante, verificando quanto la casa sia ancora il luogo deputato alla costruzione di
una narrazione formale, sociale e personale significativa e quali siano in questo senso gli strumenti progettuali adeguati. Nella convinzione che esista una relazione tra le forme che l’abitare può assumere e i significati che sottende, viene indagata quella terra di confine, quel punto critico, in cui le due polarità di base su cui si fonda ogni idea di casa, home e house, si toccano, si sovrappongono, si mettono reciprocamente in crisi.
La ricerca nasce da una consuetudine di lavoro insieme, a scuola e non solo, ma anche, da una passione condivisa che all’architettura aggiunge la curiosità,
l’apertura e il confronto con le altre discipline artistiche, nonché la passione di viaggiare, di andare a vedere di persona, di camminare con i nostri studenti dentro i
luoghi dell’abitare che ci siamo presi la briga di studiare.
B.M., S.P.
Il lavoro di ricerca si completa con la schedatura di 200 case studies, le planimetrie dei quali compongono l’Atlante Urbano della Residenza che conclude il volume; le schede complete, con disegni in scala ed immagini a colori, sono contenute nel cd allegato.
Indice
Prefazione di Carlos Martí Arís
Da Cerdà a Llinás, la costruzione lenta della città moderna
Josep Maria Sostres, il moderno come passato
Josè Antonio Coderch e il Team X
Rafael Moneo e la scuola di Barcellona attraverso le riviste degli anni settanta
Siza nella città di Schinkel
Alberto Campo Baeza, ricerca dell’unità
Alejandro de la Sota, astrazione e materia
Juan Navarro Baldeweg e il vuoto
Premessa
Quando arrivai a Barcellona nel giugno del 1998, grazie a una borsa di studio per l’estero del CNR, avevo da poco terminato la mia tesi di dottorato sulla facciata, tema di progetto sviluppato tra architettura classica e moderna, tra tipologia e forma urbana. Obiettivo del viaggio, lo sviluppo di una nuova ricerca, sotto la direzione di Carlos Martí Arís, di cui questa raccolta è uno dei frutti. Il volume, infatti, raccoglie alcuni saggi sull’architettura spagnola del Novecento: nati in occasioni diverse, spero possano dimostrarsi, nel loro insieme, un contributo alla ricostruzione di un passato recente dell’architettura iberica che influenza la situazione attuale.
Malgrado io possa attribuire questi scritti a un periodo circoscritto, è opportuno precisare le origini e il contesto di ognuno.
Il primo scritto rielabora la memoria della prima ricerca e testimonia soprattutto la scoperta dell’architettura degli anni cinquanta in Spagna, tema che avrei avuto successivamente occasione di sviluppare proprio grazie alla proposta di Carlos Martí e di Antonio Armesto di partecipare alla realizzazione di una mostra e di un catalogo sull’opera del loro maestro, Josep Maria Sostres. In quel contesto ebbi anche occasione di frequentare l’archivio di Sostres, conservato alla Scuola di Architettura presso lo studio di Pep Quetglas.
Nel maggio del 1999 la mostra fu inaugurata e il lavoro su Sostres fu sostituito da un nuovo interesse nei confronti dell’architetto madrileno Alejandro de la Sota. Nell’opera di de la Sota ritrovavo infatti la relazione stretta che lega spazio architettonico e figuratività, consapevolezza costruttiva e immediatezza dell’immagine, un tema che in modo molto diverso aveva focalizzato gli interessi della mia tesi di dottorato. Il palazzo del Gobierno Civil, la sua stretta relazione con l’arte figurativa e la storia della città antica di Tarragona, si trasformò presto nell’occasione per lavorare concretamente su un’opera, sperimentando anche un’attività di ricerca vista come approfondimento su una singola opera, dove scandagliare fasi e temi del progetto nella sua realtà, e non come confronto su temi o personalità artistiche.
Il continuo scambio tra storia e progetto, che nel frattempo avevo scherzosamente messo in gioco nell’interpretazione un po’ personale di Siza, cercava di definirsi come strumento di ricerca.
La mia formazione di progettista mi portava a riconoscere, di volta in volta, le molteplici ripercussioni di quei momenti felici sul divenire dell’architettura contemporanea. Per questo motivo, cominciai a studiare le riviste che erano state fondate e dirette dagli amici e compagni di lavoro incontrati durante l’intermezzo spagnolo: «Carrer de la Ciudad» e «2C», ma anche «Arquitecturas Bis» e «Quaderns».
Le figure di Rafael Moneo e di Juan Navarro Baldeweg, indagati all’inizio per le loro architetture, si rivelarono fondamentali per diversi motivi. Nel mosaico che stava cominciando a configurarsi mi resi conto del ruolo fondamentale che questi maestri hanno avuto: eredi dei grandi architetti degli anni cinquanta, de la Sota, Saenz de Oiza, Fisac, ne hanno acquisito la consapevolezza della costruzione, coniugandola con un atteggiamento intellettuale forse più strutturato e raffinato. Uscivano in quegli anni le riflessioni artistiche di Navarro Baldeweg e si potevano leggere, finalmente raccolti, i più importanti saggi di Moneo.
Nell’estate del 2003 feci un viaggio in Scandinavia, come i maestri spagnoli studiati avevano fatto, e ritrovai in quei luoghi molte delle immagini che avevo accumulato negli anni spagnoli. Mi resi così conto che ero andata a Barcellona attenta al pieno e ne ero tornata curiosa del vuoto, cioè della “sospensione tra le cose[1]”, come viene spesso definito lo spazio. Se ho deciso di radunare questi scritti è anche perché coloro con cui sono solita parlare d’architettura, primi fra tutti i miei studenti, siano incoraggiati a viaggiare, a confrontarsi con altri mondi, a camminare dentro le architetture immerse nella loro realtà storica e spaziale.
Mi permetto una nota autobiografica. Mia nonna porta il nome di un quartiere di Barcellona, Sempere, dal momento che nacque nel 1911 al numero uno di calle Hospital, un incrocio importante dove finisce la Rambla de Sant Josep e inizia la Rambla de Caputxins, dove la demolizione delle prime mura urbane ha dato origine, con il Raval, alla lunga storia degli ampliamenti della città, ma anche a pochi metri da uno dei luoghi pubblici più affascinanti della città, l’antico ospedale, la cui imponente struttura urbana si affaccia sulla strada ed invita all’attraversamento di un sistema urbano complesso, fatto di corti, giardini e aranceti.
Appena arrivata a Barcellona ho abitato in una stradina dietro a Calle Princesa, nel cuore della città antica, vicino alla chiesa di Santa Maria del Mar, uno degli spazi pubblici più emozionanti della città, un immenso luogo urbano coperto. La finestra della camera da letto affacciava su una piazzetta lunga e stretta: una strana forma, pensavo. Ho poi studiato che era uno dei molti frutti di una politica di riqualificazione del tessuto del centro storico che la municipalità stava sperimentando, il risultato della distruzione di un isolato della città gotica, operazione chirurgica di svuotamento, finalizzata alla diminuzione di una densità malsana e all’inserimento nel tessuto compatto della città antica di nuovi luoghi pubblici.
Quando lasciai quell’appartamento mi trasferii finalmente nel cuore dell’ensanche, in un piso molto particolare: si trattava di uno dei primi isolati costruiti sul Plan Cerdà, e l’appartamento, contrariamente a tutte le case delle manzane, non si sviluppava in profondità, ma si snocciolava in un corridoio infinito lungo il chaflán. Un’infilata di camere e porte che prospettava sul giardino tra l’università e il seminario, due dei primi edifici civili costruiti dentro le misure della manzana.
Un bel periodo l’ho poi trascorso a Gracia, dove ho sperimentato il disegno urbano degli squares londinesi che strutturano il quartiere, il cambio di scala rispetto all’ensanche e il sistema delle nuove piazze pubbliche realizzate di recente. In questi anni, negli spostamenti tra calle Asturies e calle Verdi, ho avuto la fortuna di seguire il cantiere della biblioteche pubbliche che Llinás stava costruendo a Gracia.
Questi i luoghi dell’abitare.
I luoghi della ricerca, oltre ai lunghi marciapiedi percorsi da sola o in compagnia della stessa città, erano invece sostanzialmente due, opposti e lontanissimi. Il primo: la ciudad universitaria con la Scuola di Architettura di Coderch – impossibile dimenticare sgabelli e corrimano – costruita tra gli interessanti edifici delle nuove facoltà degli anni cinquanta. Il baricentro tra il primo e l’ultimo luogo è rappresentato dallo studio di Carlos Martí sulla Gran Via, sua seconda casa in città e tavolo di verifica sempre attento e curioso. L’ultima tappa non può che essere in quel luogo condiviso da un gruppetto, già sparuto e ormai disperso per il mondo, di eterni studenti di architettura che passavano le loro giornate nella biblioteca del Collegio degli Architetti.
Vorrei ricordare gli amici spagnoli, quelli ancora vicini e quelli ormai lontani, soprattutto per ringraziarli di avermi insegnato molto. Sto parlando ovviamente degli amici di Barcellona, primo fra tutti Carlos, poi Pep, Queralt, l’ormai catalano Max, Antonio, Manuel, Gillermo, Pepe, Jaume, Ricardo, Roger e il Luca passeggiatore, ma anche i madrileni, Jose Manuel, Carmen, Javier, Monica, Luis, Josè Julio, e Luis, che ha pubblicato su «Circo» un paio di questi scritti.
Un pensiero particolare a mio padre, che mi ha sempre accompagnato con le sue provocazioni e le sue critiche, ma soprattutto le sue pressanti domande, mai scontate; a lui infatti attribuisco nelle mie passeggiate l’ansia della scoperta dell’urbano barcellonese, punzecchiata dalla curiosità di andare sempre oltre l’apparenza delle cose; a mia madre, per aver tollerato una fuga mai ben compresa, e a Bibi e Pepe, che con la loro nascita in quel periodo, scandivano un nuovo tempo. Un grazie agli amici che hanno ascoltato e condiviso racconti ed entusiasmi spagnoli, in particolare a Massimo Fortis, Annalisa, Carlo, Marco, Laura e Ilaria che mi hanno aiutato a mettere insieme e rivedere questi testi oggi.
[1] “lo que hay en el aire y entre las cosas.” lo chiama Juan Navarro Baldeweg
Alejandro de la Sota: DE LA MATERIA A L’ABSTRACCIÓN
Orsina Simona Pierini
Con el análisis del edificio del Gobierno Civil de Tarragona de Alejandro de la Sota, me interesa, mediante el recurso de la lectura critica de un proyecto construido, profundizar en una cuestión: la relación que la arquitectura puede establecer con el arte.
La tesis que se propone es aquella según la cual es posible leer el proyecto de este edificio como la determinación de una serie de problemas típicos del proyecto de arquitectura (como la relación con la ciudad o la función), la confrontación de éstos con operaciones típicas de las artes figurativas (como por ejemplo la abstracción o la materia), para llegar a establecer nuevas soluciones arquitectónicas.
He intentado plantear dos órdenes de cuestiones para el análisis de la obra: por un lado una estructura útil para la lectura de la obra, indicando algunos conceptos que la ordenan, y por otro la comprensión concreta de las modalidades de traspaso de un concepto artístico a un proyecto de arquitectura.
Son muchas las pruebas sobre la conciencia proyectual de Alejandro de la Sota. Disponemos de sus escritos, y sus conferencias, pero también de los artículos de los que han trabajado con él, Juan Navarro Baldeweg, José Manuel López-Peláez, Pepe Llinàs.
A menudo, cuando de la Sota nos habla de cuestiones importantes sobre su idea de Arquitectura, lo hace hablando de otra cosa. De la Sota, maestro moderno formado en el Madrid de la posguerra, solía a menudo acompañar sus lecciones de arquitectura con una serie de diapositivas de objetos de diversa naturaleza que él asociaba a conceptos útiles en arquitectura[1].
“El problema de hacer arquitectura es un proceso mental, una autentica resolucion precisamente de ese problema.
He comparado en ocasiones el hecho de proyectar con una partida de ajedrez a ciegas, no existe la posibilidad de “pieza tocada, pieza movida” . Es nuestra cabeza, tambien a ciegas, la que plantea con todos los datos recibidos, y como ya se indicò los que uno mismo añade, la que ha de hacer todas las posibles combinaciones que han de dar solucion a tantas posibildades..”[2]
El propio de la Sota, en el texto citado al inicio, habla del proyecto como de la selección de los elementos que pueden estar en la mente del proyectista en la fase de proyecto; habla de los materiales del proyecto y de su unidad, “tutti i dati rendono un’opera come inevitabile”, pero explica también, con la metáfora de los ojos vendados, como el recorrido no puede ser racional, lógico y enteramente descriptible, como nos recordará José Manuel López-Peláez en su artículo sobre las caricaturas.[3]
Se han recogido las palabras de Pepe Llinas, que trabajó con Alejandro de la Sota en la rehabilitación del edificio del Gobierno Civil en los ’80, cuando dice, en la introducción a los textos de Sota, que “pienso que aquello que manifiestan pudiera haber estado en el origen de la obra y, al reves, que el pensamiento que acompaña el proyecto y la obra pudiera haber originado el texto”[4]. Y así, se han podido confrontar los problemas concretos del proyecto con las reflexiones artísticas introducidas por los textos. Si pensamos en el carácter conceptual del arte moderno, en el hecho de que cada obra requiere de su público no una mirada pasiva, sino una interpretación activa tanto del proceso de elaboración como del significado final de la obra, se puede seguir la investigación que el análisis nos sugiere, estableciendo algunos conceptos clave, como por ejemplo el de abstracción o materia.
LOS PROBLEMAS DEL PROYECTO
Se trata de un proyecto de concurso ganado en 1957 y realizado en la parte nueva de la antigua ciudad de Tarragona, de orígenes romanos. El edificio se sitúa sobre una plaza circular de reciente realización, cuyo diseño criticó enseguida el arquitecto.
Posteriormente, simplemente hablando de su opción por la piedra del revestimiento, Sota introduce la fuerte relación con la ciudad antigua. La relación con la ciudad se desdobla por tanto en un rechazo del contexto real a favor de la antigua ciudad romana.
También el destino funcional viene expresamente mencionado por el arquitecto como uno de los problemas del proyecto. El edificio es la sede del Gobierno Civil, es decir el edificio del Gobernador, institución de máximo control sobre la ciudad, y aún más en la España franquista de 1957.
Su función era, por un lado, albergar las oficinas del propio Gobierno Civil, y por otro acoger la vivienda del gobernador, del secretario y de posibles invitados.
Por este motivo, el volumen se rompe en dos desde los primeros estudios, primero verticalmente y luego horizontalmente. Sota expresa ya en la memoria de proyecto la lucha con la ambigüedad del uso.
Entre los escritos de estudio de las volumetrías del edificio debe señalarse el rediseño de la torre para oficinas Johnson de Wright, donde la sección gira alrededor del vacío creado al retranquear los forjados: de la Sota estudia los maestros del Movimiento Moderno, pero los abstrae, filtrándolos a través de un problema técnico, hasta hacerlos irreconocibles. El tema del retranqueo de los forjados, de hecho, se transforma de sección en fachada principal.
La fachada es el lugar en el que se concentran y se resuelven los problemas que la ciudad y la función plantean al proyecto.
Ésta se nos presenta a menudo en una fotografía en blanco y negro, casi como una abstracción de sus llenos y vacíos, de su simplificación en cuadrados negros y de su composición sobre el plano blanco.
Es una fachada en la que el volumen cúbico de piedra se apoya sobre el vacío de la planta baja, donde solo se veen los cuatro pilares de hierro dispuestos a lo largo del imperceptible arco del círculo de la plaza, una fachada en la que los balcones y las galerías se reducen a cortes y vaciados de la piedra. La línea negra horizontal, correspondiente a la galería del segundo piso parece apoyarse solo sobre el vacío del balcón central. En la parte superior, las galerías cuadradas, decaladas, se equilibran en el proyecto de la fachada, sin expresar nada de lo que dentro encuentra lugar.
En el último piso, una casa de patio central, apoyada sobre la cubierta, casi no es visible; se trata de una pequeña villa retrasada respecto al volumen cúbico que el edificio quiere mostrar.
ABSTRACCIÓN Y MATERIA EN ARQUITECTURA
¿Puede plantearse la hipótesis de que Alejandro de la Sota experimente y encuentre en algunos conceptos del arte moderno la solución a los problemas del proyecto?
A través de los escritos y las conferencias de Alejandro de la Sota es fácil trazar una línea que se mueve dentro del arte abstracto, de Paul Klee, a Josef Albers y a los trabajos de la Bauhaus.
“Inspiraciones. Lo digo con toda humildad: siempre busco inspiraciones arquitectónicas muy lejos de mí, muy lejos del arquitecto. No me gustan los libros de arquitectura. Nunca quiero pensar que ha salido algo importante, para mí, de arquitectura que no haya sido motivado por algo muy lejano. (…) cosas que me han movido a un entendimiento, una vibración que ha sido aprovechada.”[5]
Es oportuno recordar en este punto una anécdota que Sota citaba a menudo:
“Tuve la suerte de tener la fuerza suficiente para no trabajar. (…) La buena nueva llegó de la manera más tonta. Recuerdo que fue un libro de Marcel Breuer que simplemente se llama Sol y sombra. Aquel libro hablaba de cómo protegía él las ventanas (…) le salían esculturas sin ser escultor”.[6]
Sota reconoce de Breuer el mérito de haber expresado claramente en su tratado, que acompaña sus obras, aquel movimiento, aquella idea de la unidad de los contrastes que ya el título anunciaba. Pero hay también un hilo directo que vincula a Breuer, y su libro Sol y sombra con la fachada del edificio de Tarragona y este hilo pasa a través de Semper y su idea de la fachada como revestimiento, obra de arte textil.[7]
Sota solía citar también a Josef Albers. Hay diversos temas del trabajo de Albers que reencontramos en la experimentación proyectual de Sota: el arte textil justamente, pero también el trabajo sobre los materiales y el tema del cuadrado, superpuesto al concepto de forma positiva y de forma negativa.
Una de las máximas enseñanzas de Albers es justamente el reconocimiento y el consecuente uso correcto de los materiales: “La forma depende del material con el que se trabaja”.[8]
La barandilla de la escalera principal del edificio del Gobierno Civil, plegada para ofrecer la mayor resistencia del material, parece realizada en una aula de los laboratorios de la Bauhaus, donde Albers llevaba el curso propedeutico.
“Me parece que en arquitectura hay dos maneras de hacer: la física y la química. Yo optè por la física, en la que ningún elemento se mezcla con otro para producir un tercero, sino que con unas pinzas, siempre puedas dar con toda la personalidad de cada elemento.”[9]
Muchos críticos han subrayado la importancia del uso de los materiales en la arquitectura de Sota, tan clara en sus propias palabras: “Me imagino el bien que nos haria el sentarnos ocho, diez dias sobre el bloque de granito que vamos a utilizar en aquella misma obra; estar quince años contemplando el hormigon dentro de la hormigonera, el ver kilometros de laminado de perfiles…, pequeños ejercicios espirituales.” [10]
No por casualidad Sota habla del bloque de granito. Sota es originario de Galicia, donde todo está construido en granito. Su modo de trabajar no procede por cuestiones compositivas, sino por materiales.
En la selección de los materiales del Gobierno Civil, escoge relacionarse con la antigua ciudad romana de Tarragona usando la materialidad de la piedra.
“Realmente la piedra es, con la madera, el unico material que la naturaleza nos da prefabricado, todo lo demas es, podria decirse, quimica” [11]
La ciudad romana con la que Sota escoge relacionarse es aquella que permanece en la imagen de la ciudad. Las referencias de Sota non son los bellos monumentos, sino más bien las grandes construcciones en piedra, el acueducto, la muralla y el pretorio. Su relación con la ciudad romana es suprahistórica, totalmente material.
La piedra, el material de la ciudad antigua se utiliza para construir los agujeros abstractos de la fachada del edificio.
Una fachada tridimensional que se contrapone a las fachadas laterales, donde en cambio el vidrio y las piezas de mármol tienen entre sí un espesor exiguo, explicitando la función de revestimiento. Materia excavada y tridimensional, en perjuicio de la representatividad del plano de fachada típico del edificio.
Si en la fachada principal Alejandro de la Sota pone en duda el diseño bidimensional de la fachada clásica, en las laterales sin embargo aborda un tipo diferente de proceso de abstracción que desarrollará ampliamente en su siguiente obra. Casi podríamos pensar que el revestimiento de mármol, tan ligero, consigue ocultar sólo en parte un tema tan importante para el arquitecto como es la caja de vidrio: aún escondida en este proyecto, se manifestará después en algunos otros proyectos significativos, como por ejemplo el que realizará para Aviaco.
Juan Navarro Baldeweg, pintor y arquitecto que proyectó el escudo de bronce[12] utilizado por Sota para reequilibrar los pesos de la fachada, ha escrito un artículo muy preciso, como solo un artista que obra sabe hacer, sobre la abstracción en Alejandro de la Sota[13], donde explica la diferencia entre la abstracción geométrica de un Terragni, y la inmediata, material, verificable en cambio del Gobierno Civil, que Baldeweg reconduce a Malevic[14].
Materia excavada, Malevic.
El proyecto del Gobierno Civil se presenta en 1957, año en que el escultor vasco Jorge Oteiza decide suspender su obra escultórica, interrumpir su propósito experimental.
Alejandro de la Sota ya se había interesado por Oteiza en un artículo sobre el proyecto de Sáenz de Oiza para una capilla en el camino de Santiago:
“La piedra en forma infantil, y para eso llaman a Oteiza, casi infantil en su persona, por su perfecion (…) Es necesario pensar en metales aunque usemos de piedras; las useremos de formas mucho mas pura, mas noble; contraste entre macizo, pesadez y fragilidad, ligereza. (…) La piedra, usada como niños; el metal, como puros ingenieros; y todo unido, repito, por artistas.”[15]
El propósito experimental del escultor Oteiza, se concentraba en el vaciado de la materia. Desocupación del cubo, del cilindro, de la esfera.
Su continua referencia al arte abstracto de las vanguardias surge a través Malevic, con la creación de una figura espacial vacía, infinita, dentro de un marco. Todas las esculturas de Oteiza sobre el vaciado del cubo representan la definición de los límites de un posible espacio, de un vacío predispuesto a acoger[16], tal como las infinitas piezas del Laboratorio de Tizas expresan la tentativa de representar volumétricamente esta espacialidad.
Oteiza es también escritor, de poesía, de arte y de ensayo, vasco. En su libro teórico quizás más famoso, Quousque Tandem…!, nos cuenta su infancia:
“De muy niño, en Orio,mi abuelo solia llevarnos de paseo a la playa. Yo sentia una enorme atracion por unos grandes hoyos que habia en la parte mas interior. Solia ocultarme en uno de ellos, acostado, mirando el gran espacio solo del cielo que quedaba sobre mi, mientras desaparecia todo lo que habia a mi alrededor. (…) Me van a permitir otro recuerdo: la satifaccion inolvidable, que se me despertò en la cantera, fue perforar la piedra: descubrir el otro extremo libre del agujero. (…) Es ahora que puedo asociar estos dos recuerdos. Si de escultor no hubiera concluido mi actividad experimental en un solo y simple espacio vacio, yo hubiera olvidado seguramente estos recuerdos.”[17]
Sota mira las grandes excavaciones en la materia de la ciudad romana desde el mismo punto de vista.
Sota parece interponer entre él y la ciudad el vaciado de Oteiza. Toma prestado de éstos la capacidad de arrastrar las cuestiones, de trabajar por sustracción, como la propuesta por una estética negativa que Oteiza había teorizado: “actuar creadoramente por sucesivas negaciones, en una serie progresiva de eliminaciones, fenomenologicamente, reduciendo entre parentesis todo aquello que debemos apartar para aislar el objeto verdadero que persiguimos .”[18]
Pero el análisis de la obra escultórica de Oteiza nos da otras indicaciones preciosas: en ocasión de una exposición en Sao Paulo, Oteiza produce maquetas en vidrio, con las que experimenta con la luz filtrada a través de la superposición de más planos transparentes, las paredes-luz. También en el caso del edificio la fachada se vuelve tridimensional y las galerías se transforman en cajas de luz realizadas en vidrio, excavadas dentro de la vivienda.[19]
El propio Sota, recordaba J.M. López-Peláez, hablando de su modo de proyectar solía hablar de quitarle peso. Sota solía citar a Klee para demostrar sus principios compositivos, en particular, la imagen más usada era el cuadro Casas de vidrio[20], comentado de este modo: “Una inspiracion fabulosa, la cosa que no pesa, que no se sabe como se enlaza, pero que hay un orden.”[21]
Volvamos a confrontar un cuadro de Klee y la fachada del edificio.[22] La analogia formal es inmediata, pero también entre las páginas escritas de Das bildnerische Denken de Klee podemos establecer los principios que se encuentran en el proyecto de la fachada del Gobierno Civil.
En el segundo capítulo de los Croquis pedagógicos, después de haber definido el sentido de las dimensiones, Klee se enfrenta al tema del equilibrio, llegando a ejemplificarlo con una teoría de piedras superpuestas que constituyen una torre.
Es como si Sota expresase sus dudas sobre el proyecto, su destino funcional, poniéndolo en crisis, introduciendo primero el equilibrio y el peso de las formas, y luego el movimiento del eje, explícito sobre el frente principal.
Sota esconde las dos funciones distintas, pero también la obligada representatividad del edificio, y al mismo tiempo declara su adhesión a la arquitectura moderna, a través de la abstracción de las formas. Los principios del arte moderno aparecen en fachada: líneas y claro oscuros son, de hecho, los medios plásticos primordiales.[23] Pero un ulterior concepto atraviesa la experiencia del arte moderno y las paginas del tratado de Klee: el movimiento, que en la fachada del edificio se concreta en el desequilibrio de las galerías.
“Cualquier cosa en transformación descansa en el movimento. En el Laoconte, Lessing concede mucha importancia a la diferencia entre el arte del tiempo y el arte del espacio. Pero el espacio es también un concepto temporal. El factor tiempo interviene en el momento en el que un punto entra en movimento y se transforma en línea. Del mismo modo, una línea al moverse generará una superficie; y así ocurre también con el movimento que conduce de superficies a espacios.”[24]
EL VACÍO COMO UNIDAD DE CONTRASTES
Luz, equilibrio, gravedad son los temas fundamentales de la composición escultórica, pictórica y arquitectónica de Juan Navarro Baldeweg. Dejémonos guiar todavía por sus palabras para desarrollar un último aspecto de este proyecto. Navarro Baldeweg, en la descripción de otro proyecto de Sota para Alcudia, consigue destacar una cuestión fundamental, aquella que relaciona el vacío con la unidad de contrastes.
“Los dibujos muestran una capacidad artistica envidiable para ensamblar cosas distantes en un unico impulso. Todo parece quedar definido entre extremos, cubriendo distancias en un vaiven de observaciones…
Esta manifestacion del vivir concreto està lejos de ser banal. Los dibujos conmuoven al fundir en todo momento lo necessario y el contingente, lo proximo y lo lejano, lo estatico y lo movil en diferente escalas, situaciones y ritmos.” [25]
La unidad de contrastes que hemos visto aparecer aquí y allí como tema a lo largo de este análisis es una referencia explícita a Breuer, y una referencia real en la construcción del edificio, donde la luz interna se contrapone a los agujeros negros, donde las masas oscuras del exterior se transforman en cajas de luz.
Podemos establecer con precisión al menos tres soluciones arquitectónicas de realizaciones de este vacío, más allá de los balcones ya descritos: la villa con patio central que Sota proyecta sobre la cubierta del edificio, con su planimetría introvertida; el vacío representativo de la segunda planta donde el techo se transforma en una maquina de luz y todos los elementos que lo definen parecen fluctuar, predispuestos a la realización de este espacio.[26]
Y, por último, el vacío del espacio público en la planta baja, la verdadera plaza cubierta que Sota contrapone a la banalidad de la plaza proyectada por la especulación, donde se encuentran, articulados en la posición vertical y horizontal, solo los pesados elementos de mármol, la mesa del portero y los bancos del nuevo espacio publico, que aparecen dormiendo al suelo con una modalidad muy vecina a los trabajos contemporáneos del arte minimalista.
Y que es toda la obra posterior de Sota si no la comprobación estructural, técnica y espacial de este vacío?
De hecho, podemos ver la sección del colegio Maravillas como el resultado de aquel proceso que es, en realidad, todo el proyecto del Gobierno Civil, que parte de la materia para llegar a la abstracción, experimentando y confrontando el proyecto de arquitectura con otras disciplinas artísticas.
El los croquis de estudio del gimnasio madrileño podemos observar que la inmediatez del gesto ordinario, el que sintetiza la idea del proyecto en la sección, se declina en una investigación meticulosa de los detalles y del uso de los materiales, pero sobre todo de las relaciones entre las partes y las diferentes soluciones espaciales. Al continuar el patio superior con la cubierta del gimnasio que contine las aulas, la estructura dibuja el movimiento de la gran curva y esconde la asimetría derivada de las diversas situaciones, permitiendo por una parte la iluminación directa de la sala y de las aulas y, por otra, hacia el interior, la colocación de la tribuna y del sistema de ventilación del gimnasio. La complejidad funcional se resuelve completamente en la abstracción de la sección.
La investigación de la forma tècnica se convertirá en proyectos posteriores en rasgo característico de Sota, anticipando, como por ejemplo en el proyecto para Aviaco o en el concurso para Bankunión, temas como el minimalismo de las fachadas, la excepcionalidad del vacío central o la investigación sobre los materiales transparentes y ligeros, hoy de gran actualidad.
Non es este el momento de abrir otros frentes, sino de cerrarlos recordando la costumbre de la arquitectura española de observar la arquitectura nordica, preguntándose que hay más allá del atrio de la biblioteca de Estocolmo o de la sala del Ayuntamiento de Goteborg de Asplund[27], o quizás el atrio de ingreso al National Bank de Jacobsen, si no la bellísima realización en la materia de este mismo vacío[28].
[1] “1. La bombilla. el mayor rendimiento con el menor material. 2. Paul Klee. Las transparencias. Sugerir lo inmaterial, señalar estacas en un campo, Señalar. 3. Balenciaga. 4. Mirò: color, vacío. 5. Los aviones. la mas perfecta tecnología. 6. El haz de vías. confusos y con sus leyes 7. El canal. 8. La luz en la Cooperativa de Haag, Buijs, y Lürsen. 9. Albers. El orden figurativo, la esencia que surge del plano.” Ismael Guarner, Sobre unas diapositivas de las conferencias de Alejandro de la Sota, in Bau, n. 013.
[2] Alejandro de la Sota, Memorias, in Alejandro de la Sota, Arquitecto, Madrid 1989, p. 17.
[3] “No sólo para mostrar las ideas sino también como un verdadero instrumento de diálogo entre la actividad mental y su concreción física.
(…) No se trata tanto de deformar la realidad como de cuestionarla con inteligencia y mirarla desde otro punto de vista que puede resultar sorprendente, y cuyo autor busca esa sorpresa y se divierte con ella.” J.M. López-Peláez, Caricaturas, in Circo, n. 26, 1995.
[4] Josep Llinás, Introducción, in Alejandro de la Sota, Escritos, conversaciones, conferencias, (ed. M. Puente), Barcelona 2002, p. 11
[5] Alejandro de la Sota, Conferencia en Barcelona, 1980, in Alejandro de la Sota, Escritos… cit, p. 178.
[6] ibidem, p. 171.
[7] “Lineas y planos son elementos de una construccion axiomatica del mundo, comun al arte textil, a la definicion semperiana de la tectonica y a la busqueda de las razones formales de la naturaleza en la obra de Klee e Kandinsky.” Antonio Armesto, Quince casas americanas de Marcel Breuer (1938-1965). La refundación del universo doméstico como propósito experimental, in “2G. Marcel Breuer”, n. 17, 2001.
[8] Josef Albers, in M. Droste, Bauhaus 1919-1933, Bauhaus Archiv, Köln 1998, p. 141.
[9] Alejandro de la Sota, Memorias y experiencias, in Alejandro de la Sota, Arquitecto, p. 16.
Klee lo había expresado con estas palabras. “Los elementos deben producir la forma, pero sin sacrificar su integridad. Manteniendo su identidad.” Paul Klee, Théorie de l’art moderne, Bern 1956, p. 36.
[10] Alejandro de la Sota, Alumnos de Arquitectura, in Arquitectura, n. 9, 1959, p. 3.
[11] Alejandro de la Sota, Palabras…, in Escritos, conversaciones, conferencias, p. 80.
[12] He tenido ocasión de entrevistar a Juan Navarro Baldeweg acerca del periodo de aprendizaje que pasó en el estudio de Sota y que tuvo lugar durante la época en la que el edificio estaba en construcción; Baldeweg recordaba que para Sota era muy importante que aquel bronce fuese como una vieja moneda, en la que los trazos fuesen perceptibles casi sólo al tacto.
[13] “Una pauta interna caracteriza de manera desmesurada a cada proyecto, un proceder mediante una exigente progresión reflexiva que se manifiesta paradigmáticamente en el temprano proyecto del Gobierno Civil de Tarragona. Como un proceso alquímico, la voluntad de abstracción llega al extremo de trasmutar las cosas en pura corporeidad: el edificio se eleva sobre la plaza donde se asienta como un metal ya limpio de toda escoria. El Gobierno Civil puede hacernos pensar por un momento en Terragni. Pero pronto nos damos cuenta del diferente empleo de la abstracción, lo que nos ayuda a entender su singularidad. Estamos lejos aquí de una complejidad abstracta nacida de una laboriosa génesis plástica. La abstracción que presenta el edificio del Gobierno Civil es directa, corresponde a una imagen formulada de una sola vez: se trata de una aparición repentina, más próxima a Malevic que a Mondrian. Dificilmente encontraríamos en la arquitectura contemporánea un objecto tan icónicamente precisado, tan hipnótico. Es una figura de la presencia: como tres golpes de timbal que respondieran a la espontaneidad de nuestra mirada.” Juan Navarro Baldeweg, Una laboriosa abstracción, in “Arquitectura Viva”, n. 3, noviembre 1988, p. 29-31.
[14] “El sentimento intuitivo ha encontrado una nueva belleza en los objetos – la energía de las disonancias que resulta del encuentro de dos formas.” Kazimir Malevic, De Cezanne au suprematisme, Lausanne 1974, p. 41.
[15] Alejandro de la Sota, Una capilla en el camino de Santiago, in RNA, n. 161, mayo 1955.
[16] Carlos Martí Arís, Silencios elocuentes, Barcelona 1999, p. 105.
[17] Jorge Oteiza, Quousque tandem…! Ensayo de interpretacion estetica del alma vasca, Pamplona 1963. n. 75. Oteiza no acepta la numeración de las páginas.
[18] Jorge Oteiza, ibidem, n. 63
[19] “Tambíen la luz, la idea de iluminar en profundidad, en sección, es algo tratado por Jacobsen de manera muy atractiva.”Alejandro de la Sota, Entrevista sobre la obra de Arne Jacobsen, in Escritos… cit, p. 121.
[20] Sota utilizó también el mismo cuadro para explicar su proyecto para el nuevo edificio de vidrio de Aviaco..
[21] Alejandro de la Sota, Conferencia, in Escritos… cit, p. 178.
[22] Juan Antonio Cortés, Lecciones de equilibrio, in “Anales de Arquitectura”, n. 6, 1998, p. 180-183.
[23] “El primero de estos medios es la línea, cuestión de medida solamente (…). De otra naturaleza son las tonalidades o valores del claroscuro: las numerosas gradaciones entre blanco y negro. Este segundo elemento está relacionado con cuestiones de peso. (…) el diseño es el arte de eliminar.” Paul Klee, Théorie de l’art moderne, p. 19- 21.
[24] ibidem, p. 37.
[25] Juan Navarro Baldeweg, Construir y habitar, in AV monografías, n° 68, noviembre 1997, p. 30.
[26] Pepe Llinàs, hablando de los interiores del Gobierno Civil, ha señalado que los tabiques no apoyan en el suelo:: “Las divisiones no estan sujectas a sistema formal alguno. Bailan en la superficie de la planta: no hay zocalo y, por tanto, los pies de la pared no estan aprisionados entre dos carriles que se levantan del suelo”, Josep Llinàs, Saques de esquina, Valencia 2002, p. 86.
[27] José Manuel López-Peláez, La arquitectura de Gunnar Asplund, Barcelona 2002.
[28] Basta pensar en la biblioteca municipal de la ciudad de Bergman: el atrio de ingreso de la biblioteca de Asplund es negro, con un estuco finísimo, casi reflejando la luz que entra desde la inmensa ventana-portal del ingreso. Se suben unos peldaños y uno se encuentra en la sala circular de rolor blanco de la fábrica, opaco.
El vacío del cilindro, como unidad de contrastes.
JORGE OTEIZA: DALL’ASTRAZIONE ALLA STORIA
Non vi è scritto, interpretazione, citazione, saggio o riferimento a Jorge Oteiza che non riporti con stupore la brusca interruzione del Proposito Sperimentale che lo scultore basco, nel momento del massimo riconoscimento del suo fare artistico, ha attuato alla fine degli anni cinquanta. Ma chi era e cosa stava facendo Jorge Oteiza? E soprattutto cosa avrebbe poi fatto?
Possiamo davvero parlare dell’opera scultorea, della sperimentazione formale di questo artista senza tener conto della profondità della sua cultura, quella basca peraltro così particolare, del suo mondo di riferimenti artistici, che scandaglia la storia antica e recente alla ricerca disperata di “famiglie spirituali” e del suo pensiero più intimo, nel confronto continuo con la vita e con la morte, con la realtà dell’attualità e con l’arcaico[1]?
Al momento della sua clamorosa decisione Oteiza aveva già percorso un tragitto estremamente lineare all’interno della scultura: ci ricorda con precisione Maite Muñoz come, rientrato dall’esilio in Sudamerica nel 1948, “Oteiza cerca di introdurre lo spazio nella scultura bucando il blocco originale, cerca di far convivere il vuoto con il pieno fino a far diventare lo spazio il protagonista delle sue opere”[2]. Si applicherà allo svuotamento delle figure umane, e nello stesso tempo si metterà in gioco nell’astrazione geometrica, con una ricerca sulle forme che subirà nel corso di pochi anni (la decina che si chiude nel 1958) un’evoluzione chiarissima, che possiamo riassumere in una sua frase del 1947, dove anticipava che “il vuoto deve essere oggetto di un nuovo ragionamento plastico. Il vuoto dovrà costituire il transito da una statua-massa tradizionale alla statua-energia del futuro. Dalla Statua pesante e chiusa alla Statua leggera e aperta.”[3] Nello stesso scritto annunciava anche che il significato dell’opera, “la soluzione, si trova fuori da se stessa” e che lo spettatore deve venir coinvolto attivamente nella composizione. Brevi testimonianze che anticipano il programma di vita che avrebbe affrontato solo dieci anni dopo, alla conclusione della sua fase di sperimentazione.
Ben sintetizzate nella serie dei titoli che compongono il Proposito Sperimentale del 1956/57, suddivise nei capitoli delle Dis-occupazioni di Cilindro, Sfera, e Cubo, Conclusione ed efficacemente descritte come Solidi aperti, Moduli di Luce, Aperture di poliedri, Definizione lineare di poliedro vuoto, Fusione di due Cuboidi Aperti, Associazione di blocchi di pietra (secondo la matrice Malevitch), Apertura lenta, Costruzioni vuote con unità positivo – negativo, Espansioni, Fusioni di elementi curvi, Casse vuote e Casse metafisiche, le pratiche operative si concretizzano nelle sculture da tavolo realizzate in pietra, marmo, cemento e, soprattutto, in ferro.
Le prime opere indagano i rapporti tra più forme geometriche, attraverso la loro fusione o il loro movimento nello spazio, procedimento presto criticato dallo stesso Oteiza a favore di una tensione tra le parti da generare dinamicamente e non meccanicamente; sperimentano inoltre, con le ritenzioni di luce, il lavoro con la luce come generatrice di vuoto. “Lo spazio – affermerà Oteiza nel 1957 – non si produce con lo svuotamento fisico della massa, risulta bensì dalla fusione di unità formali leggere, dinamiche o aperte, con cui si ottiene la rottura della neutralità dello spazio libero della statua.”[4] Con il concetto di fusione, con la scoperta della tensione tra le parti, si produce l’allontanamento dallo svuotamento della materia di Henry Moore e si chiarisce la portata della sua definizione di spazio vuoto.
Più tardi, sempre attraverso i titoli delle opere, Oteiza ci presenta la sua genealogia poetica: come ogni artefice, il maestro basco sente la necessità di collocare il suo lavoro in continuità con antichi e nuovi maestri; i primi, anonimi, affondano le radici nella vastità della cultura europea, come l’arcaico dei cromlech, per arrivare, attraverso Velázquez, al moderno delle esperienze astratte, prima fra tutte quella costruttivista russa. Las Meninas (il concavo e il convesso, il cane e lo specchio) Omaggio a Mallarmé, Conclusione sperimentale A per Mondrian, Omaggio a Paul Klee, sono solo alcuni dei titoli che si spingono fino all’individuazione dell’Unità Malevitch, un “quadrato irregolare con capacità di movimento diagonale.”[5] Alla sua operatività scultorea non corrisponde dunque una vita isolata dal mondo, bensì un costante approfondimento e aggiornamento sull’arte contemporanea che ha lo scopo di collocare la sua riflessione teorica in un mondo di relazioni preciso, complementare agli studi di storia dell’arte da sempre dettati dai problemi incontrati sul tavolo di lavoro.
Le ultime opere di questa serie, come le Casse vuote e le Casse metafisiche, sono così descritte dall’autore: “La mia conclusione del 1958 si realizzò con uno spazio vuoto puramente ricettivo che mi ha lasciato senza scultura nelle mani.”[6] o ancora “ho terminato in uno spazio negativo, in uno spazio solo e vuoto […] tutto il processo dell’arte preistorica europea finisce nel vuoto trascendente dello spazio vuoto del cromlech neolitico basco. […] Questo vuoto finale significa che l’arte non ha più bisogno di esplorare, che ha già elaborato una sensibilità attuale per la vita.”[7]
La cultura filtrata dagli occhi dell’artefice, prima plasmata sulla materia, serve ora a costruire l’artista stesso e il suo mondo. Oteiza lascia la sperimentazione artistica a favore della vita: intuita la logica e la potenzialità della forma, ne percepisce il fascino e il pericolo, e sceglie di limitarsi a ripetere quel linguaggio che lui stesso aveva modellato fino a attribuirgli significati diversi. Nell’abbandono graduale della funzione espressiva si esplicita il carattere di servizio che doveva prendere la sperimentazione.[8]
Gran parte del suo lavoro successivo sarà, infatti, scrivere saggi, poesia, articoli, utili a forgiare un’estetica basca, a inventarne un’origine e costruirne il futuro, usando l’esperienza formale acquisita; lo farà in molti modi, con i libri[9], sui giornali, attraverso il cinema, ma anche, ancora, con la scultura.
I temi del Proposito Sperimentale vengono selezionati, alcuni acquistano nomi eroici, espressivi del loro rapporto con il territorio – Guerriero, Odisseo – ma soprattutto subiscono un salto di scala importante e si trasformano in monumenti politici.
L’uomo pubblico si esprime a voce alta, mentre l’uomo privato, il creatore di forme chiuso nel suo atelier, non può comunque smettere di lavorare sulla materia; in quello che diventerà il suo famoso Laboratorio di gessi, le forme si confrontano e si moltiplicano alla scala più minuta, intima, in una sorta di ossessiva e cumulativa ricerca sui rapporti tra le parti. Ai due estremi della sua attività possiamo vedere il continuo ritorno ai risultati formali raggiunti nel 1958: alla scala della miniatura e alla scala immensa della sua madre terra, arroccando grandi monumenti in quella natura così pagana, costellandola di memorie di prigionieri e di manifesti politici, di guerrieri che difendono il territorio del popolo basco.
Nel gesto della disposizione di questi manufatti sulla terra si stabiliscono necessariamente rapporti complementari con il sito, si crea una tensione tra gli elementi che riempie di significato il sentirsi in un luogo, attraverso la riappropriazione del cosmo. Nel 1952 Oteiza scrive: “L’architettura e la scultura hanno in comune la creazione dello spazio. In questo caso si tratta del risultato ultimo in cui lo sviluppo dello spazio nel senso plastico si ottiene attraverso l’uso di strumenti architettonici. In contraddizione con l’idea di scultura tradizionale, che quasi sempre – compresa l’arte moderna – è una forma collocata in uno spazio esteriore, questa volta, consciamente, si è cercato di ottenere che la scultura fosse lo spazio interiore, in modo tale che entrambi gli spazi, interiore e esteriore, si integrassero”[10]. Non sta forse descrivendo la famosa scultura La Piazza dove, proprio in quegli anni, Alberto Giacometti metteva in atto il medesimo ribaltamento dello spazio?[11]
Ovviamente gli occhi attenti degli architetti spagnoli hanno colto per primi queste potenzialità della sua ricerca. Il lavoro sulla respirazione spaziale, aperta e chiusa, sulla modulazione della luce e sul cambio di scala hanno interessato non solo gli amici baschi e navarri di una vita, come Sáenz de Oiza e Fullaondo, che con lui costruirono santuari, musei e riviste, ma anche i futuri maestri della cultura iberica. Rafael Moneo già nel 1967 scriveva come Jorge Oteiza arquitecto[12] avrebbe potuto riscattare, attraverso una nuova ricerca sullo spazio, un momento difficile della cultura architettonica, involuta su questioni linguistiche, mentre il pittore, scultore e architetto Juan Navarro Baldeweg, nei suoi saggi Un oggetto è una sezione e La geometria complementare, ci fornisce gli indizi per scoprirne un’eredità nella propria poetica.
Ma la sua eredità è stata colta nella giusta profondità o è stata indagata fondamentalmente come sperimentazione formale? Come possiamo comprendere il passaggio da Fusione di due Cuboidi Aperti a Ritratto di un guerriero armato chiamato Odisseo? Come possiamo muoverci nella complessità del lavoro del grande scultore senza analizzare gli strumenti concettuali e culturali sui quali è fondata? Questo volume s’incarica, attraverso la dettagliata lettura dei molti strumenti di comunicazione utilizzati da Oteiza, di riempire di significato il vuoto delle Casse di Oteiza, inserendo il discorso formale in una prospettiva di valori più ampia.
Lo scritto di Gillermo Zuaznabar sembra essere ben consapevole del fascino e del rischio che la bellezza delle forme ci offre, così come dell’impossibilità di rinunciarvi. E scegliendo di entrare nel vivo della descrizione delle opere pubbliche principali, quali ad esempio gli apostoli della basilica di Arantzazu o il monumento al Padre Donosti, ne fornisce una rilettura che inanella quei temi e quei concetti che Oteiza aveva nascosto nella vastità della sua produzione cartacea.
Persino la costruzione della casa-atelier di Oteiza a Irun o la collocazione di una pietra scolpita sul ponte del confine con la Francia possono allora diventare parte attiva del processo di definizione dell’animo basco, e insegnare a conoscere la particolare prospettiva con cui Oteiza ha interpretato la storia della sua terra e il suo paesaggio, attraverso la vita e la morte, l’arcaico e il contemporaneo, il tempo e lo spazio. Un lascito che i giovani artisti con il cappello alla Beuys, che si aggiravano nel padiglione centrale dell’ultima edizione di Documenta a Kassel, hanno percepito inconsapevolmente nell’ammirare stupiti la gigantografia del Laboratorio di gessi.
[1] “La contemporaneità s’iscrive, infatti, nel presente segnandolo innanzitutto come arcaico e solo chi percepisce nel più moderno e recente gli indici e le segnature dell’arcaico può essere contemporaneo. Arcaico significa: prossimo all’arké, cioè all’origine. Ma l’origine non è situata soltanto in un passato cronologico: essa è contemporanea al divenire storico e non cessa di operare in questo […] Lo scarto, e insieme la vicinanza, che definiscono la contemporaneità hanno il loro fondamento in questa prossimità con l’origine, che in nessun punto pulsa con più forza che nel presente.” Giorgio Agamben, Che cos’è il contemporaneo?, Roma, 2008, p. 39.
[2] María Teresa Muñoz, Prólogo. Arte, ciencia y mito, nell’edizione critica di Jorge Oteiza, Interpretación estética de la estatuaria megalítica americana, 2007, p.45, T.d.A.
[3] Jorge Oteiza, “Del Escultor Oteiza por el mismo”, in Cabalgata, Buenos Aires, 1947, T.d.A.
[4] Jorge Oteiza, Propósito Experimental, presentato a São Paulo do Brasil, 1956-57, T.d.A.
[5] “Malevitch rappresenta l’unico fondamento vivo delle nuove realtà spaziali. Nel vuoto del piano ci ha lasciato una piccola superficie, la cui natura formale leggera, dinamica, instabile, fluttuante occorre capire in tutta la sua portata. Io la chiamo Malevitch”. Jorge Oteiza, Propósito Experimental, Op. cit., T.d.A.
[6] Jorge Oteiza, “Pobreza aparente de mi escultura », in Cartas al principe, Zarautz, 1988, p.65, T.d.A.
[7] Jorge Oteiza, Quosque tandem …! Ensayo de interpretación estética del alma vasca, Auñamendi, Donostia, p. 77, T.d.A.
[8] Daniel Fullaondo, in Nueva Forma, n° 28, maggio 1968, p.21, T.d.A.
[9] “Per Oteiza la pagina bianca è campo di operazioni simile al blocco di pietra o a qualsiasi altro materiale, perché gli serve per scegliere alcuni elementi, stabilire relazioni tra questi, introdurre metafore e, a partire da tutto questo, creare una nuova entità.” María Teresa Muñoz, Op. cit. p.58, T.d.A.
[10] Memoria del proyecto del escultor Oteiza presentada al concurso international para el monumento al prisonero politico desconoscido y protesta ante el jurado, Londra 1952, in RNA, 1952, T.d.A.
[11] Oteiza ha sempre mostrato un’attenzione particolare all’artista svizzero, riconoscendo nella sua opera un’analogia con la sua ricerca sullo spazio. In Quosque tandem …! dice Oteiza sulla scultura di Giacometti: “Dimagrimento della figura della rappresentazione o disoccupazione spaziale della statua come necessità spirituale di un vuoto recettivo figurato”.
[12] Rafael Moneo, “Jorge Oteiza arquitecto”, in Forma Nueva, n° 16, maggio 1967, p.22, T.d.A.